 Immagine @ Pixabay
Immagine @ PixabayDisse il filosofo Martin Heidegger che il linguaggio è una casa dentro cui abita l’uomo: e come ogni casa, rappresenta chi ci vive. Per questo il termine “paesofia” non poteva che nascere in quest’epoca da un lato di riscoperta dei piccoli centri come nuova dimensione dell’anima, dall’altro di un crescente bisogno di riconnessione con l’elemento naturale e infine di presa di coscienza del drammatico problema dello spopolamento delle aree interne, a qualunque latitudine, problema dalle molteplici sfaccettature e conseguenze.
Recita il Dizionario Treccani che lo ha appena riconosciuto come neologismo: “Il paese, il piccolo centro abitato caratterizzato da ritmi quotidiani distesi, come dimensione consona al pensiero filosofico e alla riflessione”.
La citazione di Heidegger e la presenza del suffisso “-sofia” sono indizi inequivocabili circa la professione di chi per anni ha perorato la causa di “neologismizzazione”, nonché inventore di questa nuova parola che va a implementare i nostri dizionari, nonostante il linguaggio veloce dei social cerchi di impoverircelo: Gianluca Galotta insegna proprio filosofia e storia a Roma e tutto è nato dal suo libro intitolato, appunto, Paesofia. Filosofia e viaggi nei piccoli paesi (pp. 176, 15 euro, La Scuola di Pitagora Editore 2021), con la prefazione di Leonardo Caffo.
La parola
Il termine “paesofia” fa dunque riferimento a una tendenza sociale diffusa, e nasce proprio per sistematizzare l’insieme di comportamenti esplosi con la pandemia, ma sostenuti anche da un crescente disagio sociale figlio di una globalizzazione smodata, della crisi economica, nonché delle ansie di natura climatica (anche “eco-ansia” in effetti è un recente neologismo), a cui ora si aggiungono le preoccupazioni per le guerre in corso, più impellenti delle altre 140 che da tempo si combattono nel mondo nell’indifferenza generale.
La tendenza a riscoprire il piccolo, a viaggiare dietro casa, a guardare con attenzione ciò che prima si vedeva distrattamente: l’alpinismo di prossimità scoppiato grazie alle restrizioni pandemiche ne è una ulteriore prova.
Cogliendo bene queste vibrazioni sociali, Galotta ha dunque proposto un suo approccio, derivato dalla personale esperienza di viaggio attraverso i piccoli paesi dell’Appennino centrale, quelli dove pulsa la ferita dell’abbandono, nelle crepe dei muri diroccati assaltati dal bosco che avanza senza più nessuno a prendersene cura. E osservando il tessuto sociale rimasto, piccolo, ma tenace, ha capito che queste terre alte sono ormai uno dei pochi baluardi di civiltà, non semplici luoghi da visitare più o meno turisticamente (nell’accezione più neutra e comune del termine), ma spazi che ci invitano ad aprire nuovamente il cuore, a fermarci, a rallentare, a riconnetterci. Spazi dove abita una “saggezza” che rende il viaggio un’esperienza di trasformazione personale.
È questa la “paesofia”: la saggezza dei piccoli paesi, con la loro antica eredità di tradizioni, mestieri, con la sapienza di mani capaci che non hanno bisogno di manuali per capire la terra, in grado di insegnare a noi frenetici consumisti di città che rallentare è possibile.
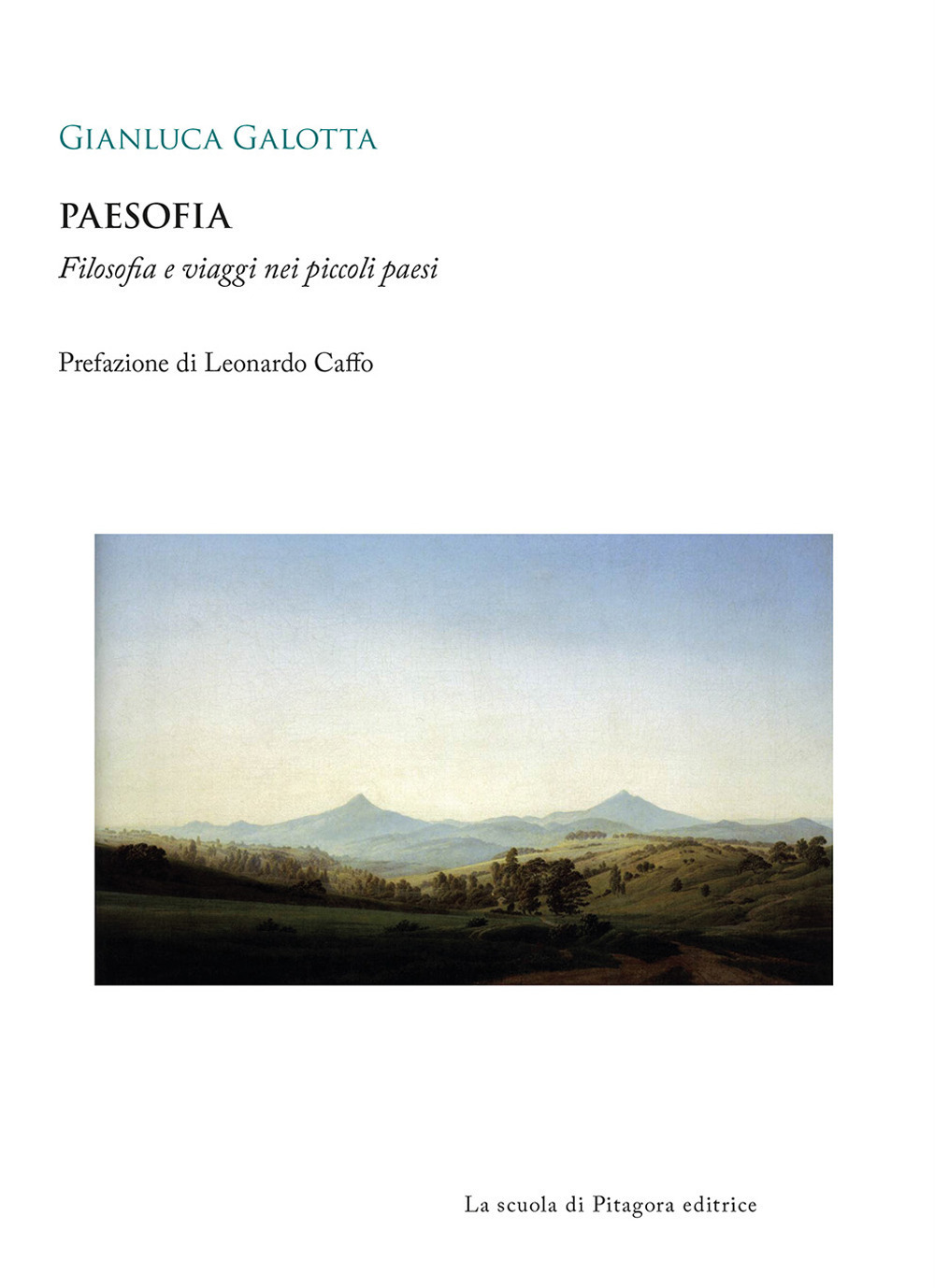 La copertina del libro “galeotto”, pubblicato nel 2021.
La copertina del libro “galeotto”, pubblicato nel 2021.Una filosofia per il Sentiero Italia
Sarà che Galotta vive e lavora a Roma, ma di famiglia è abruzzese di Rivisondoli, 1300 metri di quota e appena 600 anime in provincia de L’Aquila, dove si trova uno degli oltre 500 punti tappa del Sentiero Italia CAI. Siamo nel Parco della Maiella, nell’Alto Sangro, e qui arriva il tratto di 16,51 km che giunge da San Pietro Avellana (990 m), per ripartire verso Barrea (987 m) dove si arriva dopo aver camminato per ben 21,13 km, e un saliscendi di oltre 1300 metri. Tutti i dettagli si trovano nel volume 5 delle Guide ufficiali del Sentiero Italia (Molise, Abruzzo, Lazio, Marche, Umbria. Da Isernia a Bocca Trabaria, di Marta Zarelli, Francesco Cappellari e Corrado Gentile, pp. 480, 32 euro, 2021, disponibile su CAI Store).
Non a caso citiamo il Sentiero Italia, il grande sogno dei “visionari del trekking”, come si chiamarono Riccardo Carnovalini, che ne fu l’ideatore, Giancarlo Corbellini, Teresio Valsesia e i molti altri che nel 1983 costruirono l’idea di unire l’Italia con una “autostrada verde” che passasse proprio dai paesi di montagna, sull’esempio di altre esperienze europee e dell’allora neonata GEA, la Grande Escursione Appenninica. Un’idea testata sul campo proprio 30 anni fa, nel 1995, quando partì il primo CamminaItalia che fece appunto scoprire le montagne italiane in tutta la loro bellezza e fragilità, accendendo forse per la prima volta l’attenzione sulle aree interne che già da tempo si andavano svuotando a favore delle caotiche metropoli, sempre più indifferenti ai bisogni degli umani che le prendevano d’assalto innanzitutto per necessità occupazionali.
La paesofia allora non esisteva ancora nel nostro vocabolario, ma è ragionevole pensare che Carnovalini e i cinquemila camminatori che accompagnarono lui e i suoi compagni nel viaggio alla sua fonte bevettero più di una volta, lungo i 6.000 km (poi sviluppati fino agli attuali 8.000 circa) che percorsero, da Santa Teresa di Gallura in Sardegna a Muggia vicino a Trieste, risalendo la dorsale appenninica e poi traversando l’arco alpino, a volte a mezza costa, a volte un po’ più in cima, ma sempre mantenendosi là dove pulsa, tutt’oggi, il cuore della montagna antropizzata con sapienza.