Una nuova strada che salverà l’economia di un paesino di montagna collegandolo con il mare e il disastro ambientale che invece provocherà, un vecchio omicidio scabroso dimenticato per quieto vivere, la Prima guerra mondiale appena scoppiata e un ragazzino di 14 anni che non vuole tornare in collegio: sono gli elementi dell’avvincente storia di Neve di maggio, di Marco Tomatis (pp. 160, 13,50 euro, Notes Edizioni 2024). Il libro era già uscito 10 anni fa con altro titolo in realtà, ma questa versione, pur mantenendo la trama, ne rappresenta una riscrittura integrale al presente e in prima persona. Intatto si mantiene il registro che arriva dritto alle orecchie dei suoi lettori (dai 12 anni) perché semplice e suggestivo al punto giusto, capace di affrontare con delicatezza anche argomenti duri e drammatici.
Sono davvero molti i temi sul piatto, la guerra costituisce in realtà solo uno sfondo storico funzionale a parlare dell’argomento portante, come spiega l’autore, dello sfruttamento del territorio, e a dire però che ogni guerra è orrore e si combatte sulla pelle dei più poveri. Il protagonista – che vive quell’età di passaggio che è l’adolescenza in cui non è più un bambino e non ancora un adulto – inizia ad affacciarsi in un mondo dove cambiano le regole, dove i grandi non si rivelano sempre così saggi, dove la fiducia verso il prossimo, anche se è il proprio padre, non si può dare per scontata, perché ogni scelta può avere conseguenze importanti per la vita di molte persone. E dove è il momento di prendersi il coraggio di affermare la propria volontà.
L’ambientazione in montagna è normale per Tomatis, socio CAI a Mondovì di lungo corso, compare anche nel recente Judith (Giunti 2024), che racconta le vicissitudini di una ragazzina ebrea polacca, scritto a quattro mani con Loredana Frescura, come tanti altri, destinati a bambini e ragazzi (ma Tomatis ne ha scritto qualcuno anche per gli adulti). La rodata coppia ha vinto un premio Andersen nel 2006 con Il mondo nei tuoi occhi (Fanucci Editore) e nel 2017 il prestigioso Premio Cento per la letteratura per ragazzi con Massimo da sistemare (Giunti), i loro libri sono tradotti anche all’estero.
Tomatis ormai è in pensione, ma nella vita ha fatto l’insegnante e per qualche tempo anche il preside, esordendo nell’editoria come sceneggiatore di fumetti. È così che ha conosciuto sua moglie, l’illustratrice Cinzia Ghigliano (galeotta fu Lea Martelli, uno dei primi personaggi femminili del fumetto italiano), con cui ha pubblicato spesso per riviste come “Linus”, “Corto Maltese”, “Il Corriere dei piccoli”, ma anche “Amica”.
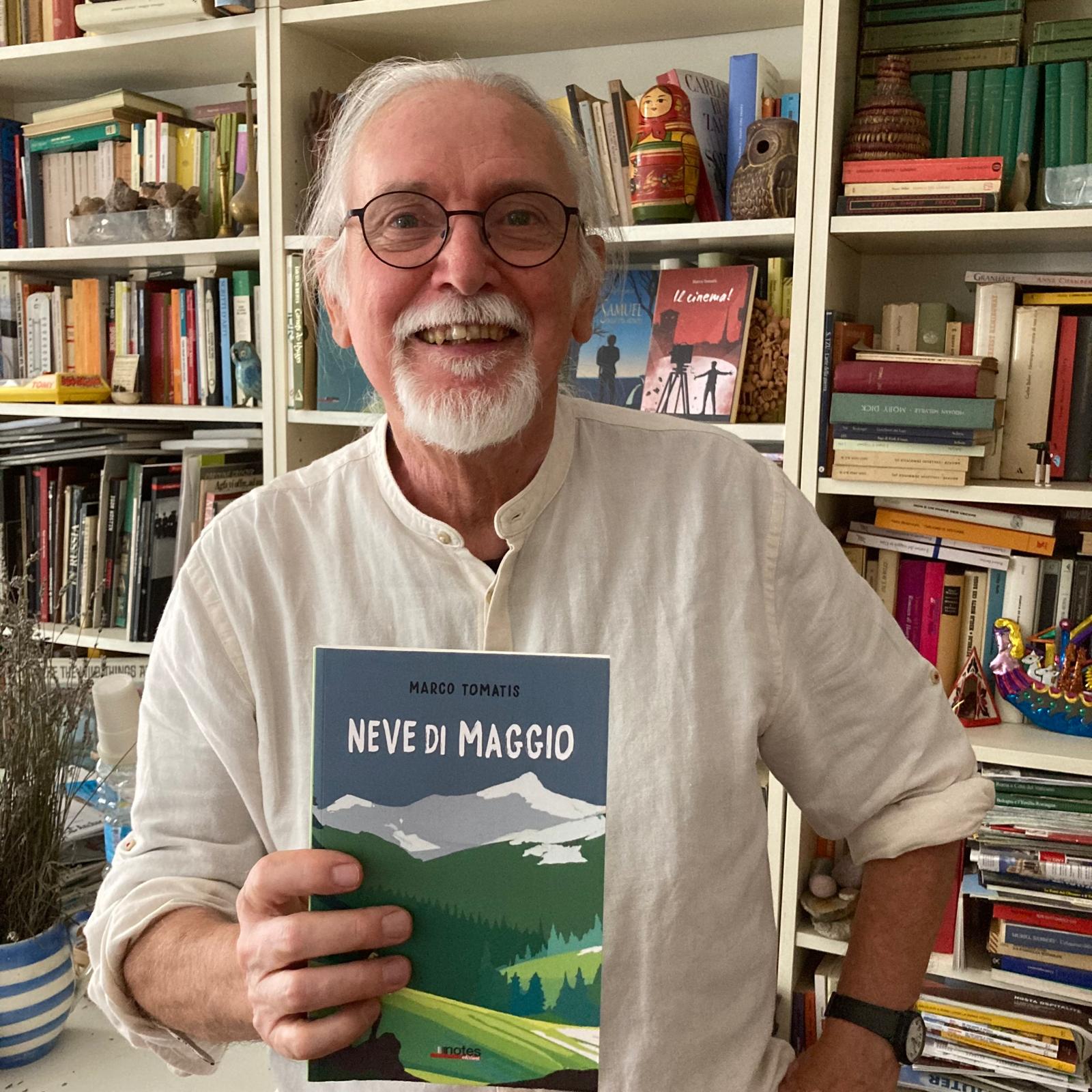 Marco Tomatis, foto dell'autore.
Marco Tomatis, foto dell'autore.
Marco Tomatis, perché i tuoi libri sono spesso ambientati nel periodo delle due guerre mondiali?
Perché uno dei temi che mi sta più a cuore è lo sfruttamento della montagna in senso turistico ed è negli anni ’30 e ’40 che inizia, è allora che si pensa alla montagna come fonte di reddito e si costruiscono strade, come succede in questo romanzo. Proprio lo sviluppo tecnologico delle teleferiche per i rifornimenti degli appostamenti in quota è alla base dei successivi impianti sciistici di risalita.
Uno dei temi forti della storia è però il rapporto delicato fra sostenibilità ambientale e sviluppo economico in chiave anti-spopolamento, come si conciliano?
Questo è il tema che saltava sempre fuori quando giravo a presentare la prima edizione del libro. Io non ho risposte, ma penso che sia importante parlarne per fare riflettere i giovani sulla sostenibilità ambientale. Io vivo nel cuneese, nei luoghi di sbocco delle vallate – come Mondovì o Borgo San Dalmazzo – dove i montanari scendevano a fare i rifornimenti per l’inverno, e lo spopolamento l’ho visto a cavallo degli anni ’50 ai ’60 (Tomatis è del ’47, NdR): alcuni miei compagni di scuola venivano dalla montagna e si erano trasferiti scappando da standard di vita ormai troppo bassi. Quindi capisco i compromessi, ma le stazioni sciistiche a bassa quota non hanno futuro…
I luoghi dove si svolge la storia sono inventati, ma a quali paesaggi attingi?
Non ho voluto dare indicazioni reali perché avrebbero potuto sorgere polemiche, considerando la trama di un sindaco corrotto e di un disastro ambientale, ma Castello è un toponimo che in diverse forme ricorre molto nelle vallate liguri come in quelle friulane. Le descrizioni richiamano le zone a me care delle Valli Monregalesi delle Alpi Liguri, ma con qualche aspetto dolomitico. Il Colle del Sale di cui parlo, per esempio, si ispira al Passo delle Saline delle Alpi Cuneesi, zona carsica, dove un tempo si praticava il contrabbando, come su tanti colli.
Sono zone che frequenti?
Sono socio CAI della Sezione di Mondovì da metà anni ’60, con una sospensione fra gli anni ’70 e ’80 per alcuni problemi, ma ho l’Aquila d’Oro per i 25 anni. Non sono mai stato un alpinista in senso verticale, ma un escursionista, adesso con l’avanzare dell’età faccio un po’ di meno, ma almeno una volta a settimana cammino con un mio amico e quando insegnavo, con altri colleghi appassionati di montagna come me, portavo i ragazzi della terza media a fare un trekking dalle nostre parti. La montagna è sempre stata una “maestra di vita” per me, mi ha insegnato a sapere calcolare le mie forze e su quali contare, consapevole che se sali poi devi scendere. Mi guida l’immagine di Primo Levi della “carne dell’orso”, non l’ho più scordata. Della montagna io ho una visione contemplativa, vado e godo di quel che c’è intorno, ma in tanti anni l’ho vista cambiare: prima c’erano quelli che “lottavano con l’alpe”, adesso si va in ferrata coi bambini in braccio. Qualche settimana fa ho visto uno con le infradito su un sentiero impervio, gliel’ho fatto notare, mi ha detto che era abituato così…
Un posto a cui tieni?
Il mio luogo del cuore è il Rifugio Havis de Giorgio, che tutti in realtà chiamiamo Rifugio Mondovì, l’ottimo gestore che la tiene lo conosco da una vita, ci vado da quando avevo 16 anni. Mi piace anche andare in Val di Susa, nelle Valli di Lanzo, nel Cuneese… e visto che sono un appassionato di storia cammino anche fuori dall’Italia. Ho fatto un trekking in Slovenia, a Caporetto, trovando zone abbandonate all’incuria, anche se ne sono rimasto affascinato.
Hai insegnato per 40 anni, che messaggio vorresti fare arrivare ai tuoi lettori?
Come non penso che ci sia differenza fra libri per ragazzi e per adulti, ma solo fra buoni e cattivi libri, io non lascio messaggi, e fra l’altro la letteratura per me non deve dare messaggi, al massimo suggerirli. Il primo libro l’ho pubblicato negli anni ’70 e da allora mi sono sempre divertito a scrivere e girare l’Italia per le presentazioni, lo trovo gratificante. Nei miei libri metto i valori in cui credo e sono quelli che devono arrivare. Qui in particolare il rispetto per la natura e per il prossimo, che la politica spesso dimentica.