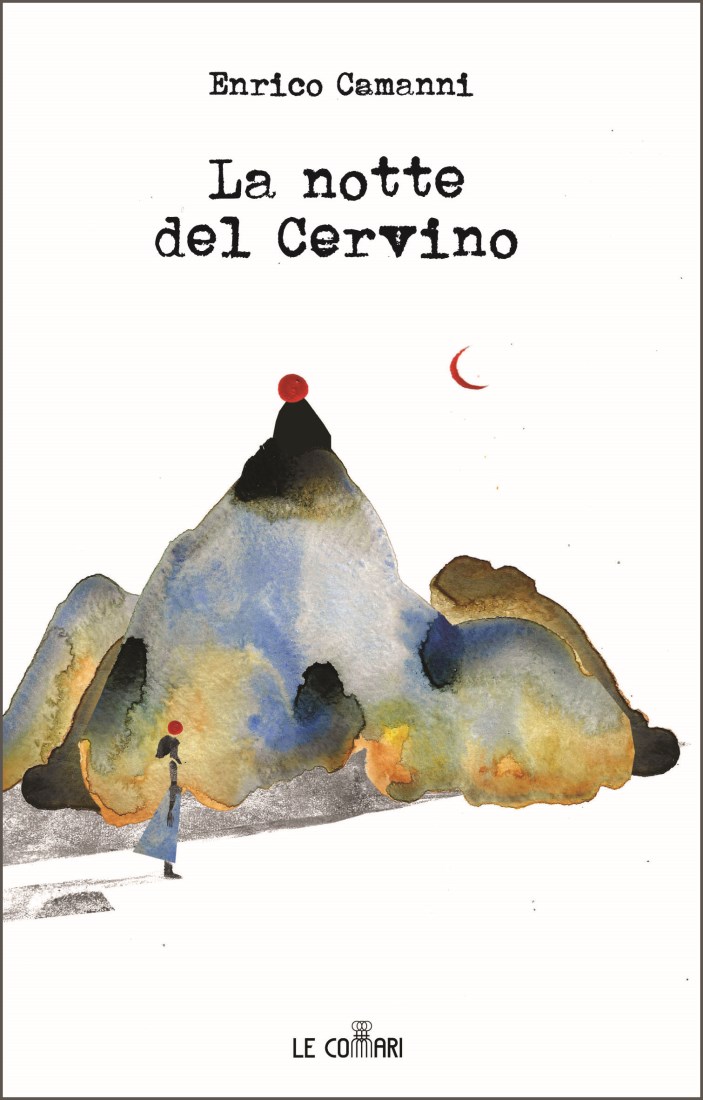
A 20 anni dalla pubblicazione, torna in libreria “La notte del Cervino”, il primo romanzo di fantasia di Enrico Camanni (pp. 202, 18,00 euro, Le Commari 2023). Ambientato fra gli anni ’60 e ‘70, fino a sfiorare la soglia del millennio, racconta la storia di Chiara, che a 20 anni faceva la rivoluzione in piazza a Torino con gli operai della Fiat e a 30 si ritrova giornalista per un quotidiano di provincia a Ivrea, storica sede della Olivetti, dove lavora anche suo padre. In una manciata di anni la sua vita si stravolge: si innamora di Franco, suo nuovo direttore, e perde suo padre, ma anche la sua migliore amica, Anna, che ha scelto la strada della lotta armata. Sarà il Cervino a riannodare alcuni fili e spezzarne altri.
Nel romanzo si stratificano diversi livelli di lettura: quello socio-politico, quello montanaro e quello delle relazioni umane. Sullo sfondo scorrono i principali eventi degli anni di piombo, dalla strage di Piazza Fontana allo sbarco sulla Luna, dall’uccisione di Aldo Moro a quella di Guido Rossa, dalle contestazioni studentesche alla morte di Papa Luciani, per dirne alcuni. La penna di Camanni, classe 1957, si posa in maniera delicata ma precisa sui grandi fatti come sui piccoli sentimenti, forse perché quando ha scritto il libro aveva quell’età che non è più giovinezza e non è ancora vecchiaia, ma ha la maturità che consente di guardare noi stessi e il mondo con una consapevolezza addolcita da un pizzico di nostalgia. Ne risulta un libro ancora attuale che svela la parte più intima di un alpinista che ha percorso centinaia di vie sulle Alpi, anche nuove, di uno studioso che si è occupato di alpinismo da un punto di vista storico, ambientalista e sociale, ma soprattutto di un giornalista che ha contribuito a rivoluzionare il modo di parlare di montagna. Questo si faceva con “La rivista della montagna”, dove entrò nel 1977 nemmeno ventenne, sotto la direzione di Giorgio Daidola che succedeva a Gian Piero Motti. Un’impostazione proseguita e rilanciata fondando “Alp” nel 1985, diretto per 13 anni fino alla chiusura. Sono migliaia gli articoli pubblicati negli anni su riviste e quotidiani, innumerevoli le collaborazioni con mostre, film, università.
 Enrico Camanni
Enrico CamanniEnrico Camanni, perché un romanzo e perché una donna?
Quando ho scritto “La notte del Cervino” avevo già pubblicato due romanzi storici, “Cieli di pietra”, dedicato ad Amé Gorret, e “La guerra di Joseph” su una guida del Cervino. Per un giornalista è più facile raccontare persone reali, per quanto in maniera romanzata, basta fare ricerche e interviste. Avevo invece da tempo il desiderio di passare alla narrativa, avevo anche scritto dei racconti lunghi, ma non possedevo la metrica del romanzo. Con quei due libri devo essermi sbloccato e a quel punto ho deciso di buttarmi del tutto, scegliendo come protagonista una donna. Anche perché la grande rivoluzione degli anni ’60, che io non ho vissuto perché ero troppo giovane, l’hanno fatta loro, quindi un personaggio femminile era più interessante».
Il libro è ambientato fra Torino e Ivrea, ma anche nei dintorni, paesini come Brosso in Valchiusella o Piamprato in Val Soana, nel Canavese, ci sono montagne famose come il Monviso e il Cervino, ma anche il Soglio, la Quinseina e il Mombarone. Sono tutti descritti minuziosamente, ci sei stato spesso?
«Sono luoghi che mi hanno sempre affascinato dal punto di vista ambientale: l’ambiente è sempre presente nei miei libri, lo trovo più difficile da descrivere di un personaggio e passo molto più tempo a farlo. Da quelle parti sono passato spesso e poi a Ivrea c’è stata la Olivetti, il vescovo rosso Bettazzi, che è morto lo scorso luglio. Non ho vissuto quel fervore, ma me lo sono fatto raccontare e alcune cose sono vere, come la tovaglietta della trattoria, o l’episodio dei fascisti al Lago Sirio».
La storia d’amore fra Chiara e Franco sviscera temi profondi. Innanzitutto, l’evoluzione degli ideali di gioventù, Chiara lo chiamerebbe imborghesimento. Tu hai vissuto il Nuovo Mattino, cosa resta oggi?
«Ho appena pubblicato il libro su Gary Hamming, anche lui incarnava quelle istanze rivoluzionarie. Penso che siamo tutti debitori di quell’epoca in ambito di montagna. Oggi siamo liberi di fare ciò che vogliamo, di non salire una cima e di non svegliarci per forza presto, di vestirci e di comportarci come ci pare, allora invece eri considerato un emarginato, un anarchico se non seguivi quei dettami. È successo anche a me perché usavo le scarpette da arrampicata, e non ero nemmeno fra i primi. Due anni dopo ce le avevano tutti, era cambiata la mentalità. Questo è il grande lascito, su cui poi abbiamo costruito, bene o male. Vale lo stesso per i diritti civili: allora si è iniziato a parlare di divorzio, di aborto, di diritti delle donne, di aprire i manicomi. Oggi li diamo per scontati, anzi, sembra quasi che ci vogliamo rimangiare certe aperture, anche se penso che ormai indietro non si torni, siamo troppo cambiati».
Si parla anche di fede: Franco è cattolico, per quanto non un baciapile come all’inizio lo vede Chiara, che invece religiosa non è. Religione e alpinismo non sono mai andati molto d’accordo, eppure il progetto “Una montagna sacra per il Gran Paradiso” (il Monveso di Forzo), a cui hai aderito, ha messo insieme tante anime diverse. Perché dobbiamo chiamare in causa il sacro per salvare le montagne?
«Sto scrivendo un libro su questo argomento, uscirà in marzo con Laterza. Il sacro ci parla del nostro rapporto con la natura. La montagna sacra per me è una provocazione culturale che serve ad avviare un cambiamento, potrebbe essere anche una foresta o un lago, il tema di fondo è la necessità di darci dei limiti, di non pensarci più come i padroni della Terra, e questa è una delle possibilità per farlo, non è l'unica ma è utile. Non è un tema che nasce come un fungo, ma ha una storia lunga che parte dal turismo di massa per esempio. Chiara non è un’atea convinta, ma è una che cerca, che dialoga. Per me non esistono verità assolute: come si fa a dire che c’è un unico dio? L’importante però è cercare».
Restare a vivere nei luoghi natii o andarsene. Sugli squilibri dell'antropizzazione del paesaggio e sullo spopolamento delle aree interne montane hai molto scritto e ti sei occupato, anche da vice-presidente dell’associazione Dislivelli, dove convergono diversi studiosi del progetto “Riabitare l’Italia”. Cosa significa avere una visione innovativa della montagna?
«Oggi ci sono due montagne, come sto scrivendo nel nuovo libro. Una è consacrata al turismo di massa, è piena di cose, ha bisogno di crescere sempre e non fermarsi mai, per non soccombere alla concorrenza. Col riscaldamento climatico avrà un enorme problema di riconversione e lo affronterà alla sua maniera “pesante”. Poi c’è una montagna povera, spopolata, senza servizi. Credo nel lavoro lento, ma duraturo, di chi resta per costruire una comunità (non di eremiti col computer!) ed è capace di riabitare quei luoghi anche grazie ad attività di turismo lento, oppure all’agricoltura biologica, ma sempre in ottica collettiva. Non ne hanno bisogno solo le montagne, ma anche certi quartieri delle città. La prima dinamica segue una strada obbligata, la seconda è più creativa. “Le otto montagne” di Cognetti sono riuscite a raccontare bene questo tipo di storie: non si è montanari per sempre o per forza».
Il rapporto con l’amore, la morte, la malattia, con un padre che si ama e si odia: quanto hai messo di tuo nel raccontare questi temi in modo così preciso?
«Rileggendomi oggi mi sono stupito in realtà di come ne avevo scritto. All’epoca i miei c’erano entrambi, forse però il fatto che mio padre fosse un medico mi ha avvicinato all’ambiente degli ospedali e al tema della malattia. Invece era forte per me, molto più di come lo è oggi in generale, lo scontro generazionale con lui».
Perché il Cervino finisce per essere sempre una montagna così speciale? Quando ci sei salito la prima volta?
«Per me è speciale perché i miei mi portavano sempre a Valtournenche in vacanza. Ma speciale lo è di suo, ti strega, anche se poi quando sei in cima ti rendi conto che è fatta di roccia come le altre. Da bambino sognavo di stare lassù, ma quando ho realizzato il mio sogno è stato fin troppo semplice: è successo quando avevo 16 anni, ho messo da parte i soldi facendo il baby-sitter tutto l’inverno e ho pagato una guida che mi accompagnasse in vetta».
Hai lavorato nelle redazioni di settore con ruoli importanti, di cosa dovrebbe assolutamente occuparsi una rivista oggi?
«Viviamo ormai sommersi dall’informazione, se ne occupa ogni canale, social o non social. Quando lavoravo alla “Rivista della montagna” e pubblicavamo gli “Itinerari scelti” correvano tutti a comprarli e a farli, perché non avrebbero saputo come altrimenti trovare quelle indicazioni. Ma non sono un catastrofista, su internet ci vado anche io: quello che manca però è un ragionamento sulle cose. Una rivista, secondo me, deve essere capace di cercare persone competenti in grado di fornire pareri interessanti e dare loro spazio, come sta facendo la “Rivista del CAI”. C’è ancora tanto da fare».