Antonio Soressi è un artista ormai affermato quando la morte del padre lo costringe a tornare dalla Francia nel paesino dove è nato. Ma a Concabella, come un pubblicitario aveva chiamato negli anni Trenta la nuova stazione sciistica nelle Prealpi, Antonio deve fare i conti con il passato: con l'uccisione di cinque giovani partigiani, che dopo tanti anni tormenta le coscienze di chi è sopravvissuto al fascismo indipendentemente dalla parte che scelse, e con i più recenti ricordi della sua famiglia e del luogo. La montagna delle illusioni di Paolo Paci (pp. 368, 19,90 euro, Piemme 2024) è un libro complesso, ambientato in un territorio montano inventato, ma verosimile, devastato prima dall’attività estrattiva, poi dall’industria della neve. Geograficamente si spinge fino alle Calanques provenzali con il loro “mare verticale”, e persino oltreoceano.
Addentrandosi nella lettura, sorge il dubbio che le illusioni di cui parla non siano solo quelle di chi si fece abbagliare da un futuro economico costruito su una neve effimera. Serve una buona dose di onestà intellettuale per rendersi infatti conto che la storia sfugge alle etichette che le sono state appiccicate.
C’è indubbiamente la critica a un’economia aggressiva che del territorio ha abusato. C’è il cambiamento climatico e la constatazione che il futuro è irrimediabilmente diverso da come lo immaginarono le generazioni precedenti. Ma Paci, direttore di Meridiani montagne, alpinista e giornalista di lungo corso, affronta questi temi rifuggendo giudizi e sentenze, con una prospettiva storica che ci aiuta ad analizzare l’oggi con lucidità, prendendo coscienza della fisiologica ambiguità che ci caratterizza.
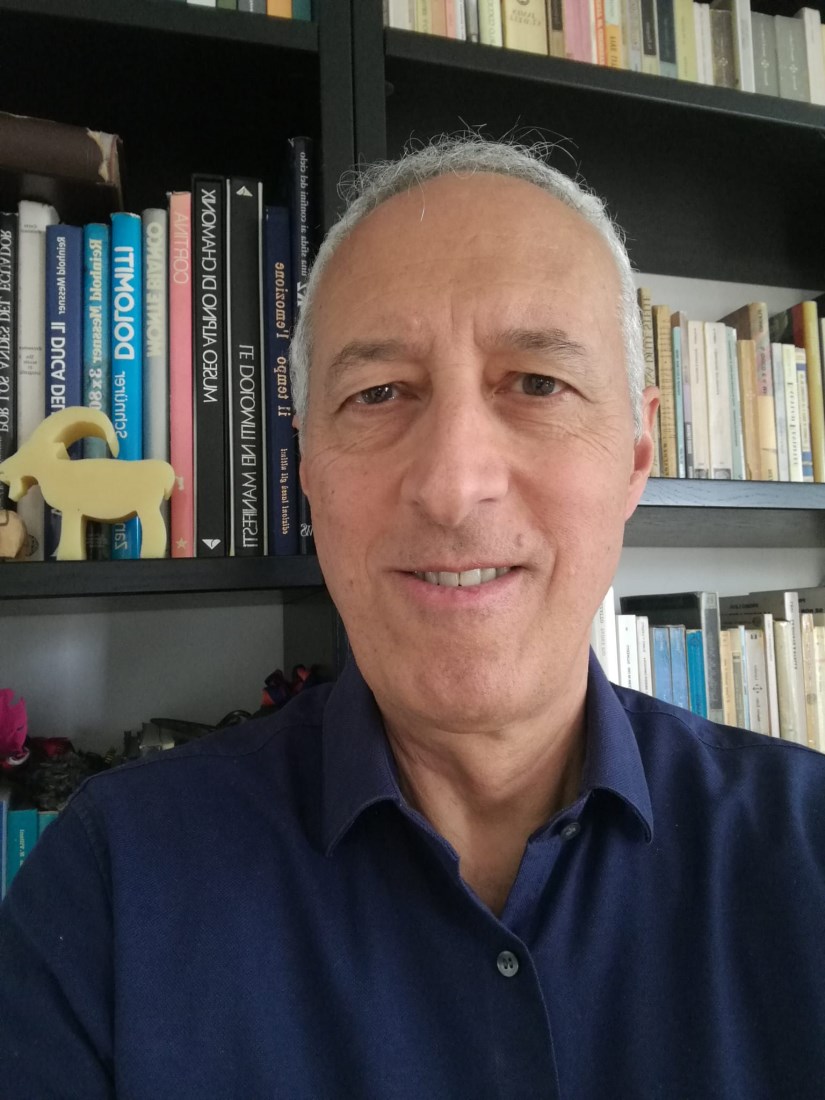 Paolo Paci, foto dell'autore.
Paolo Paci, foto dell'autore.
Paolo Paci, con una provocazione si potrebbe dire che la montagna è “inutile”, tranne che per gli alpinisti e gli artisti? Cos’hanno in comune?
Hanno entrambi lo stesso sguardo sulla montagna, quella “alta”, al di sopra della linea dei pascoli, inutile perché economicamente non serve a nulla, non ci si coltiva, non si scia, ma invece stimola una visione artistica. L’alpinista ci vede linee di salita e placche, spigoli, pareti, come una composizione cubista di vari elementi geometrici non diversa dalla visione dell’artista. Quando il protagonista Antonio, da piccolo, disegna la montagna con cubi e triangoli, ne coglie in fondo l’essenza.
All’arte attribuisci una libertà di giudizio che nemmeno un magistrato può avere. Per questo il tuo protagonista è un artista?
Sono un appassionato di arte, soprattutto contemporanea, una realtà con cui mi sono sempre imbattuto nei miei reportage di viaggio, visibile in modi diversi in città e in montagna. Il nostro protagonista è un ribelle, uno che sceglie di non fare la professione del padre o dei nonni. Il suo rifiuto dell’ambiente da cui viene passa attraverso scelte intellettuali e professionali che lo portano su un altro pianeta: è un personaggio poliedrico. Non fa la guida alpina, né il rifugista, il maestro di sci o il cavatore di pietra. È un pregiudizio pensare che chi nasce in montagna debba fare per forza certi mestieri. Pensiamo a Giacometti, nessuno avrebbe potuto dire che dalla valle svizzera da cui viene sarebbe uscito un artista di caratura mondiale.
Però in fondo il protagonista ha bisogno di tornare al suo luogo di origine per poter andare avanti, deve un po’ fare pace con il suo passato per ritrovare la sua identità. Si tratta di questo?
Non si tratta di fare pace, ma di accettare l’ambiguità delle cose, il fatto che la montagna sia bella e brutta insieme, che dà la vita e dà la morte, che può essere il paradiso pastorale e l’inferno turistico. Tutte queste sfumature vanno accettate per fare pace con se stessi, ma a che scopo ritrovare la propria identità? Ci si può creare un’identità nuova e migliore, come fa Antonio, che a un certo punto chiude la sua storia con una valle sempre ripiegata su se stessa, sui propri temi, sulle proprie angosce, sui suoi litigi tra famiglie, e va a Chicago verso il suo futuro.
Sull’ambiguità gira tutto il romanzo. La stessa ricerca della verità intorno alla morte di cinque giovani partigiani ci porta a constatare che il mondo non è bianco e nero e che tutti i personaggi e le loro azioni vanno riletti alla luce del finale.
Il libro è giocato sull’ambiguità perché noi non siamo personaggi scolpiti nella pietra, ma persone che cambiano, come la montagna, come il clima. Tutti i personaggi nel libro sono ambigui: i giovani partigiani uccisi forse non sapevano neanche quello che stavano facendo. I cattivi della storia alla fine in parte si redimono. E quelli che sembrano essere buoni, nel racconto si scopre forse che non lo sono fino in fondo..
Il cambiamento climatico sconvolge tutti i piani economici locali. Non a caso il libro è ambientato nel 2003, la prima estate davvero torrida.
Quell’estate con la mia famiglia ero scappato dal mare nella nostra casa di Foppolo, ma nemmeno lì, a 1600 metri, riuscivo a sentire quell’aria frizzante che c’era sempre stata e per la prima volta ho sentito sulla mia pelle che qualcosa stava cambiando. Come sempre nasce tutto dalle mie esperienze…
Foppolo è uno dei luoghi a cui ti sei ispirato per inventare Concabella, con Cervinia e Sestriere, le grandi cittadine della neve, ma alla fine non sembrano esperienze del tutto negative. È solo un’impressione?
Foppolo nella Val Brembana è la base geografica, ma è tutto spostato in alto di 500 metri, visto che lì non ci sono ghiacciai, possiamo immaginarci un luogo tra Alpi e Prealpi lombarde. Il paese invece è più come Cervinia, dove negli anni ’50 e ’60, avendo campo libero, si sono esercitati grandi architetti, anche la scuola Mollino è passata da lì, producendo interessanti architetture moderne. Me ne sono occupato in altri libri e trovo che definire brutto quel posto sia limitante, frutto di una visione parziale. Oggi pensiamo come sia stato possibile rovinare la cartolina del Cervino, per me invece quello che emerge è sempre l’ambiguità dell’uomo nel paesaggio. Questo libro parla di luoghi antropizzati: le cave, gli impianti sciistici. I grattacieli estranei alla tradizione, ma non dimentichiamoci che anche i pascoli rappresentano un paesaggio modificato dall’uomo, non esisterebbero senza l’attività dei pastori. Per questo non esprimo giudizi estetici. A Foppolo come a Cervinia siamo di fronte a paesaggi modificati dalla nostra presenza, che possono piacere o non piacere, ma attenti a essere troppo manichei.
Non ti scandalizza nulla?
Se vedo una bella architettura che stona con il paesaggio non mi scandalizzo. Prendiamo la polemica sui rifugi che rovinerebbero le Dolomiti. Non si è forse fatta la stessa cosa 100 anni fa costruendo nello stile dell’epoca? La presenza dell’uomo segna sempre il paesaggio, che sia coi tetti a spiovente o con un modulo spaziale dipende solo dall’epoca in cui vive.
Non dovremmo porci dei limiti?
Io sono stato e dentro mi sento ancora e prima di tutto un alpinista. A voler essere onesti fino in fondo allora dovremmo fare come sulle Montagne Rocciose: non costruire niente. Le Alpi potrebbero essere una riserva integrale, uno di quei parchi dove non si esce dal sentiero. È difficile dire qual è la strada giusta, perché non c’è, abbiamo costruito troppo o troppo male. A me quello che dà più fastidio è l’abbandono del manufatto. Quello che abbiamo costruito dovremmo continuare a usarlo sempre, altrimenti è meglio non costruirlo. Ogni riferimento alla pista di Bob di Cortina è voluto. Il bello e il brutto non mi interessano, è l’utilità a fare la differenza.
Allora è l’utilità l’unico limite?
Anche i modelli economici insostenibili, come Foppolo, dove si sono costruiti condomini anziché alberghi e nuove piste: anziché ampliare l’offerta alla fine questa diventa solo una furia edilizia che non porta da nessuna parte. Quella è la distruzione del paesaggio, quando non c’è equilibrio tra quello che si sta facendo e la possibilità che ciò sopravviva. E infatti non sopravvive, a Foppolo è tutto in vendita. Anche in altri posti dove non si scierà più ci saranno città abbandonate con valori immobiliari ai minimi storici. Sarebbe stato meglio costruire meno condomini e più alberghi, ma soprattutto creare un’offerta in grado di farli lavorare tutto l’anno.
Non è ancora troppo forte la mentalità che vede nella montagna solo un posto dove si scia?
Il cambiamento climatico ci ha messo di fronte platealmente a questa contraddizione, di cui ci saremmo accorti in pochi. Ora se ne accorgono tutti che quei modelli non erano sostenibili, al di là del giudizio moralistico o estetico. Ma non ci sono modelli virtuosi sulle Alpi.
Nessun modello virtuoso?
Pensiamo al Cervino: da una parte c’è Cervinia, dove si è sperimentato dal punto di vista architettonico con risultati secondo me anche pregevoli, dall’altra parte Zermatt costruita tutta sul modello culturale fasullo dello chalet svizzero, che non ha fatto altro che consumare territorio, perché se singolarmente gli chalet sono carini, tutti insieme visti dall’alto diventano mostruosi. A Sestriere, piuttosto, sono rimaste solo delle torri circolari, espressione riuscita dell’architettura razionalista degli anni Trenta, non c’è una città invasiva e si scia pure bene, perché è abbastanza alto, ma dubito che potrebbe essere considerata bella. Il punto di equilibrio lo abbiamo forse raggiunto negli anni Settanta e Ottanta, quando si giustificavano queste città artificiali perché c’era tanta neve e c’era uno scopo economico, anche se i grossi investimenti sono stati fatti nei decenni successivi. Erano tutti felici, lo sci stava diventando uno sport di massa e ancora non si sapeva che saremmo arrivati a questo punto. Oggi siamo fuori equilibrio.
 Paolo Paci.
Paolo Paci.