 Mauro Varotto. Foto Archivio Film Festival della Lessinia.
Mauro Varotto. Foto Archivio Film Festival della Lessinia.È uscito Il primo libro di geografia, l’ultimo lavoro di Mauro Varotto (pp. 272, 23 euro, Einaudi 2025). Varotto ha coordinato e diretto, nel 2019, il primo Museo universitario di Geografia all’interno dell’Ateneo di Padova, dove è Ordinario di Geografia e Geografia culturale. Ha diverse pubblicazioni all’attivo: prima di questa, Montagne di mezzo (2020) e con Temo Pievani Viaggio nell’Italia dell’Antropocene (2021) e Il giro del mondo nell’Antropocene (2022). E proprio nella montagna di mezzo vive, a Posina, ai piedi del Pasubio, 700 metri per 500 anime, da “abitante politopico”, categoria da lui stesso analizzata e studiata, quello che si sposta in base alle esigenze, alle stagioni, agli animali. “Lavoro a distanza grazie a internet – dice – ma la legna me la taglio da solo e mi coltivo le patate”. L’alpinismo è una passione e un ricordo di gioventù: qualche ferrata, qualche ascensione, poi una frequentazione più consapevole che sempre più ha messo da parte l’ansia di raggiungere la vetta come unica ragione dell’andare. E insieme agli studi sui ghiacciai, in particolare la Marmolada, che misura da vent’anni, sono subentrati quelli sui “segni dell’uomo” in collaborazione con il Gruppo Terre Alte del CAI di cui è stato coordinatore. Infine, l’identificazione con i montanari “veri” grazie al trasferimento là dove lo sguardo cambia davvero e viene governato da esigenze concrete che lasciano molto meno spazio all’immagine poetica della montagna.
Nonostante il titolo da sussidiario delle elementari, dettato da ragioni di collana, il libro è il saggio di un accademico, che di accademico conserva solo il rigore scientifico, essendo scevro dell’ingessatura che di solito caratterizza le pubblicazioni di questo genere. Si rivolge a chi intraprende gli studi universitari in questo ambito, o a chi vuole colmare una lacuna molto diffusa nel nostro Paese, dovuta al pessimo insegnamento della materia fin dalla tenera età.
Se la prima categoria è probabilmente composta da giovani che hanno già capito il senso e l’importanza della geografia, è agli occhi della seconda che, capitolo dopo capitolo (ce ne sono venti), essa si svela come un mondo nuovo, non certo come insieme di dati statici da apprendere a memoria, quale viene propinata a scuola. A nessuno di quelli probabilmente è stata spiegata con la mitologia, tantomeno con il Piccolo Principe, la cui citazione apre il libro.
Si ha la sensazione che la geografia appresa sui banchi non fosse che la punta di un iceberg: la lettura di queste pagine, così ricche di osservazioni e domande dal sapore filosofico, ci restituiscono un quadro estremamente più complesso, ma anche affascinante di una disciplina che trova nel concetto di relazione il suo senso più profondo. Una geografia “che non si occupa più solo del ‘dove’, ma si chiede anche il ‘perché’ e il ‘come’ diamo significato allo spazio che ci circonda”.
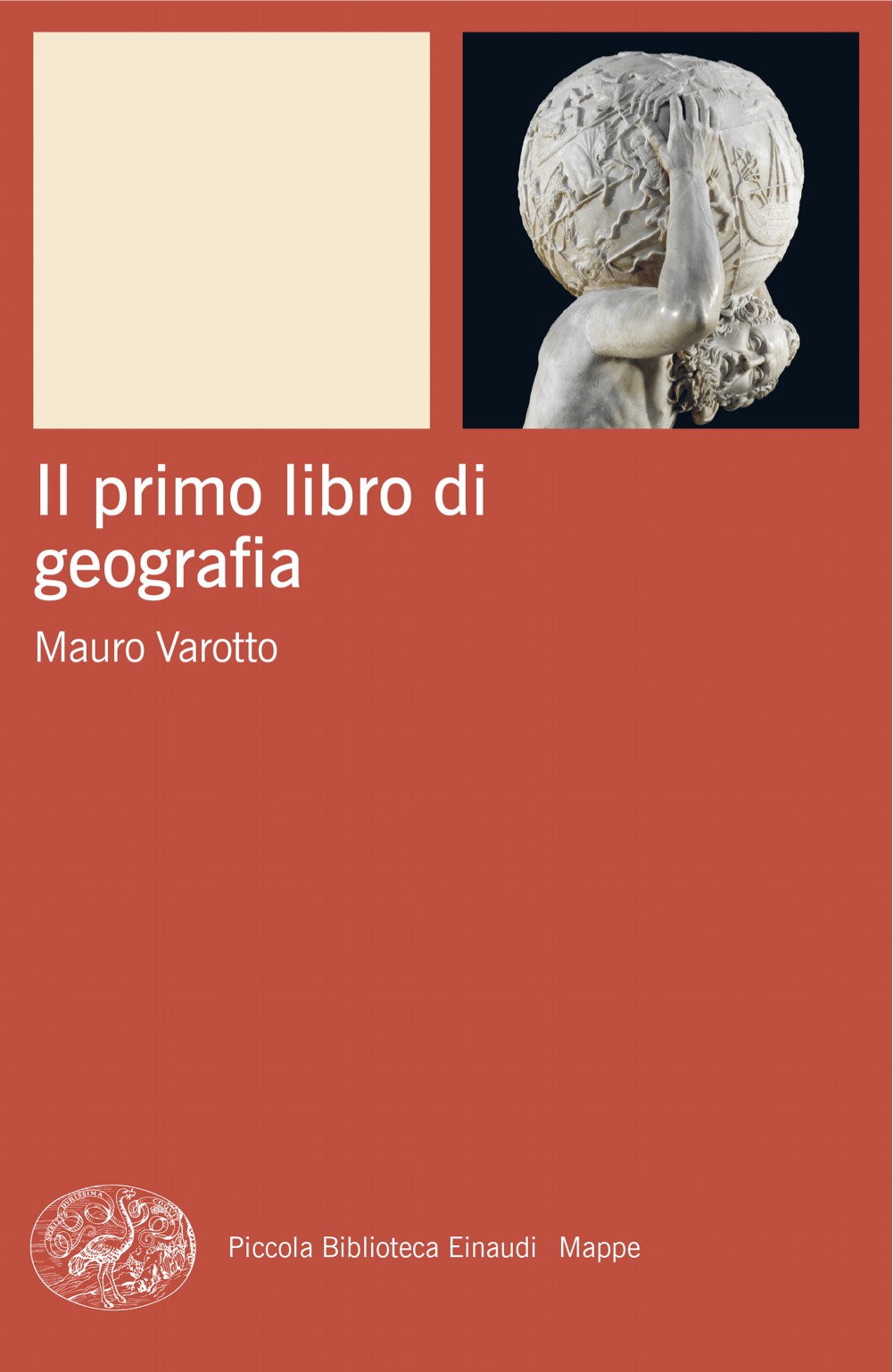 La copertina del libro.
La copertina del libro.Mauro Varotto, da dove nasce la sua passione per la geografia?
Quando ero bambino mi divertivo a collezionare francobolli: erano come finestre sul mondo, li mettevo in ordine per stato, ognuno con il suo colore e la sua forma, e poi li andavo a cercare sul globo. Ho intrapreso un percorso di studi umanistici, passando dal liceo classico alla Facoltà di Lettere, dove in realtà pensavo di studiare storia delle religioni, invece ho seguito l’indirizzo geografico, perché all’epoca non c’erano ancora le classi di laurea in Geografia. Ho dato 7 esami di geografia su 20, studiando ogni declinazione possibile, e da lì il dottorato.
La “nuova geografia” di cui lei è promotore è però molto distante da quella che si studiava ai tempi.
Negli anni ’90 si studiava essenzialmente la geografia fisica, di stampo più matematico e quantitativo, per la semplice ragione che chi la insegnava aveva una formazione scientifica, con una laurea in Geologia o Scienze naturali. Da allora sono cambiate un po’ di cose e si è affermata, anche in Europa, una visione più culturale della geografia, attenta anche al modo in cui noi diamo significato allo spazio, definendolo e concettualizzandolo. Questo libro porta in quella direzione, invitando a riflettere sul modo in cui ci comportiamo nello spazio e sulle ricadute concrete di ogni nostra azione su quello.
Dall’anno prossimo i programmi scolastici cambiano (torna il latino alle medie, alle elementari si studierà la Bibbia), ma non per la geografia, che si insegna ancora poco e male. Qual è il rischio di una sempre più diffusa “ignoranza geografica”?
L’ignoranza nozionistica è sempre più crassa, perché ritenuta inutile visto che ormai c’è Google. Ma quando poi uno spegne il cellulare dovrebbe avere le coordinate essenziali, senza dipendere totalmente dal web: bisogna sapere che Cuneo si trova in Piemonte anche senza consultare Wikipedia, dovrebbe far parte del nostro bagaglio culturale. Ma a preoccuparmi di più non è questo.
Cosa la preoccupa?
Ignoriamo che siamo in continua relazione con lo spazio in cui viviamo e questo produce delle conseguenze, anche se inconsapevoli. Capire meglio la complessità di queste relazioni serve ad avere maggiore cognizione di causa. Penso al cibo: conoscere la provenienza di un alimento non è in automatico prova di qualità, ma almeno ci rende più consapevoli di ciò che mangiamo. Lo spazio è cultura, territorio e politica e noi dovremmo conoscere la specificità di ogni spazio per poterlo interpretare con le categorie giuste, che è la geografia umanistica, oltre che politica o fisica, ad consentirci di trovare, aiutandoci a collegare il dove al perché.
Politica, territorio, cultura: nel capitolo sulla montagna sono concetti che spiccano particolarmente. Lei sottolinea l’importanza di parlare di montagne, al plurale, come mai?
Intanto per uscire dalla stereotipizzazione della montagna che tende a privilegiare uno sguardo esterno ed estraneo, tipicamente urbano, dominante perché chi frequenta di più la montagna vive in città. Solo adesso ci accorgiamo delle ricadute negative che ha una montagna pensata solo per il turismo, oppure idealizzata e considerata solo come natura incontaminata. Una visione altrettanto pericolosa, secondo me, perché troppo semplificata, derivata dall’idea che la montagna è tanto più pura e tanto migliore, quanto più rarefatto è l’elemento umano. È un tema che affronto anche nel capitolo sulla natura. Parlare di montagne al plurale aiuta a riconoscere la specificità dei luoghi, dando valore alla loro complessità e alla loro diversità.
“Montanari di ritorno” e “overtourism”: due opposti che non si attraggono?
Le traiettorie si stanno invertendo: conosco persone che vanno a vivere in montagna ma volutamente non in quella più turistica, e non solo perché è più accessibile economicamente. Sono scelte alternative. Paradossalmente, se in passato il turismo serviva a sostenere la montagna, oggi che diventa l’ingrediente dominante finisce per schiacciare le esigenze di chi ci vive. Per diverse ragioni (di evoluzione economica immobiliare o di fruizione concentrata nel tempo e nello spazio) diventa un cappio al collo degli abitanti. Per questo chi torna a vivere in montagna sceglie luoghi intermedi, dove c’è più spazio, ma soprattutto una visione della montagna un po’ diversa, dove si punta anche su altri settori e attività, più vicina a chi la abita.
Abbiamo di recente assistito a due fatti di cronaca che sembrano antitetici, ma sottintendono un identico atteggiamento irrispettoso: l’invasione di 10mila persone a Roccaraso, e le Lamborghini trasportate in rifugio col gatto delle nevi. Come trovare un equilibrio?
L’evoluzione territoriale delle montagne nel ‘900 è caratterizzata da due estremi: da un lato la progressiva intensificazione del fenomeno turistico, dall’altro l’abbandono. Che non è un destino biblico scritto nel cielo, ma l’esito di politiche che lo hanno di fatto incentivato, soprattutto a livello nazionale. Parlo di Italia, perché Svizzera o Austria, che sono stati alpini, hanno dovuto far coesistere in qualche modo queste due dimensioni. Non si può uscire dalla montagna e rientrarci solo nel tempo libero, come turista. Serve una politica per l’agricoltura e per l’allevamento in montagna, per il settore forestale, che nel nostro Paese è ampiamente sottoutilizzato, per via della retorica che tutela l’albero per compensare le emissioni di CO2, prodotte però altrove. Questa è una visione “coloniale” della montagna, da preservare in quanto compensazione di una vita trascorsa lontano da essa. Ho cercato di delineare un’alternativa nella ricerca della medietas nel libro Montagne di mezzo: la montagna non può essere per tutti in senso quantitativo, ma deve esserlo in senso qualitativo. Deve accogliere il turista, ma a sua volta quel turista deve rendersi conto che la montagna non è solo per lui, lì abita anche qualcun altro, un boscaiolo, un malgaro, un artigiano…
La politica non ha aiutato, diceva.
In molti casi le politiche per la montagna sono state carenti, provocando una crisi evidente, anche se sono state emanate più leggi, ma spesso senza adeguate risorse alle spalle, a parte la Strategia Nazionale per le Aree Interne, che ha provato a invertire la tendenza negli ultimi dieci anni. Altrimenti le regole generali del funzionamento economico rimangono quelle della produzione industriale, che in montagna è una via difficile: privilegiare la concentrazione, la specializzazione, la standardizzazione produttiva significa farla morire. Forse bisogna intendersi su cosa sia la montagna…
Cos’è la montagna?
Se consideriamo montagna solo i comuni al di sopra di una certa quota (600 metri, NdR), ma non la relazione tra la dimensione ambientale e quella umana, si finisce a fare in montagna ciò che conviene economicamente, nel modo in cui lo si fa in città.
“Metro-montagna” o “montagna di mezzo”?
Sono due concetti in parte convergenti, in parte dagli accenti diversi: la “metro-montagna”, con quel “metro” davanti che rimanda a “città metropolitana”, si concentra sulla necessità di garantire in montagna gli stessi servizi e opportunità che ci sono in città. La “montagna di mezzo” invece mette l’accento più sulla dimensione di mediazione con l’ambiente montano in tutte le sue peculiarità, possibile ovviamente se ci sono i servizi. Non per niente la metro-montagna nasce a Torino la cui area metropolitana arriva fino al Monviso, mentre la montagna di mezzo prende spunto dall’addomesticamento ereditato dai montanari nei secoli passati. Non basta andare in montagna per abitarci, bisogna mettersi in dialogo con la sua eredità storica e ambientale specifica. In questo senso montagne di mezzo propone un cambio di baricentro, dalla dimensione puramente individuale (soggettiva) a quella relazionale (intersoggettiva) con uno specifico ambiente, con piante, animali e uomini della montagna.
Come si colloca in questo quadro il rapporto uomo-natura di cui si parla tanto oggi?
Prima cosa: tutti parliamo di natura, ma non è detto che tutti intendiamo la stessa cosa, essendo un concetto astratto, una costruzione culturale. Secondo: dobbiamo rompere questa dicotomia che vede opposti da un lato l’uomo e dall’altro la natura, tipica della modernità. Bisogna invece riconoscere l’umanità che c’è negli spazi naturali, ereditata dal passato, e la naturalità dentro l’umano. Noi conserviamo una parte selvatica, ma bisogna imparare a riconoscerla dentro e fuori di noi, per evitare che venga strumentalizzata.
Per esempio?
Prendiamo i concetti di biodiversità e del tanto predicato “equilibrio” che si porta dietro: circola spesso l’idea che se un luogo viene abbandonato allora ritorna a uno stato di equilibrio naturale. Quale equilibrio? Quale biodiversità? Quella del paesaggio terrazzato o del bosco che lo ricopre? Non c’è una sola biodiversità e non c’è un solo equilibrio. Sono concetti culturali che evolvono. Se smontiamo questa scatola pezzo per pezzo, capiamo che anche nel nostro quotidiano possiamo riconnetterci con la natura, senza bisogno di andare in montagna o di creare riserve naturali integrali. Non esiste una ricetta unica e neanche un’unica regola, e il grado di natura non si misura semplicemente con l’assenza dell’uomo. Anche l’azione umana può avere un ruolo biodiversificatore, se rispettosa: pensiamo a tutte le cultivar dell’agricoltura che ha creato. È natura anche quella.
Niente montagna sacra, insomma?
Ho scritto un articolo sul tema: rispetto molto chi lo teorizza, ma è un concetto orientale che non può funzionare trasportato da noi. Molto spesso si considera tale solo la vetta di una montagna, di fatto distinguendo montagne di serie A e di serie B (quelle più basse). Se la montagna sacra vuole essere un simbolo, e un invito a fermarsi, allora prendiamo il simbolo per antonomasia dell’alpinismo, il Monte Bianco, altrimenti la trovo una scelta insignificante. Ma poi, se vado in montagna prendendo tutte le attenzioni, la sto davvero profanando? Ho fatto le scuole medie dai frati francescani e sono sempre stato allergico a una dimensione del sacro confinata soltanto nel tabernacolo, anche se etimologicamente sacro rimanda a un recinto. Ma quel recinto a sua volta rimanda a fuori: dobbiamo capire che il concetto di sacro rimanda al rispetto della relazione. Ed è forse questa la cosa più sacra che abbiamo: il rispetto degli altri.
 Mauro Varotto in Marmolada. Foto autore.
Mauro Varotto in Marmolada. Foto autore.