 Anna Torretta, una foto dal suo sito www.annatorretta.com
Anna Torretta, una foto dal suo sito www.annatorretta.com«Un rifugio mio non lo gestirei mai, però se lo facesse una delle mie figlie perché no. Meglio che fare la guida alpina!». Scherza Anna Torretta quando afferma che non le piace troppo parlare con la gente. «Non vado a cercare la conversazione, non ho mai troppo tempo». O forse è troppo convinta del suo mestiere di guida alpina per cambiarlo con quello (durissimo) di rifugista. «Se lavori in rifugio poi smetti di andare in montagna, perché non hai più la libertà di farlo, e io non riuscirei». In fondo nemmeno Giovanna Zangrandi fece quella scelta, dopo aver costruito l’Antelao per amore, nell’estate del 1946, come racconta ne Il campo rosso. Per amore delle montagne che da lì si potevano ammirare (le Marmarole, i Monfalconi, gli Spalti di Toro), quelle dove aveva combattuto nella Resistenza con le Brigate Pietro Fortunato Calvi, e per amore di Severino Rizzardi, conosciuto proprio durante quell’esperienza, ma ammazzato dai tedeschi il 26 aprile 1945. Era con lui che aveva sognato di costruire un rifugio, di fare una famiglia, di tornare a vivere, superando l’orrore della guerra.
Gira il libro fra le mani, Anna (Anna come il nome di battaglia di Zangrandi quando fece la staffetta): «Mi colpisce molto la sua scrittura, non la conoscevo e ho iniziato subito a leggerlo, le pagine scorrono via facilmente». Una scrittura priva di retorica, come ha ben rilevato Paola Lugo nell’introduzione al volume.
Ripensa ai rifugi del cuore: «Sono particolarmente affezionata al Rifugio Vittorio Emanuele al Gran Paradiso, il primo dove ho dormito, in 40 anni non è cambiato più di tanto. E al Monzino qui sul Monte Bianco, oggi gestito in modo interessante da una coppia, per come è stato costruito e per la posizione in cui si trova», ovvero tra i ghiacciai del Frêney e del Brouillard, in Val Vény. Un rifugio storico, che nel 1965 ha preso il posto della Capanna Gamba, dove appena quattro anni prima Walter Bonatti era giunto stremato, nel luglio 1961, l’estate della tragedia che lo vide protagonista al Pilone Centrale del Frêney dove persero la vita quattro compagni su sette.
Per una guida alpina il rifugio può essere un luogo di lavoro, dove passare una notte con i clienti per spezzare una salita impegnativa, ma anche un punto di ritrovo: con i colleghi, con cui condividere esperienze o aggiornarsi sulla propria famiglia, e i rifugisti, che ogni tanto diventano amici, come appunto sul Gran Paradiso, e a cui riportare le condizioni del terreno. «Oggi si cerca di fare tutto in velocità, ma non è il tipo di alpinismo che concepisco io».
Da tempo proprio i rifugisti denunciano la moda dell’alpinismo mordi e fuggi, simbolo di un turismo non rispettoso del luogo in cui si svolge, esattamente come il CAI denuncia l’evoluzione “glamour” di certe strutture che del rifugio conservano solo l’estetica. «Sicuramente oggi in rifugio non si mangia più solo pasta al sugo e magari pure scotta. Quanto alle ostriche in rifugio, meglio ricordare che per affrontare la salita sono poco digeribili…».
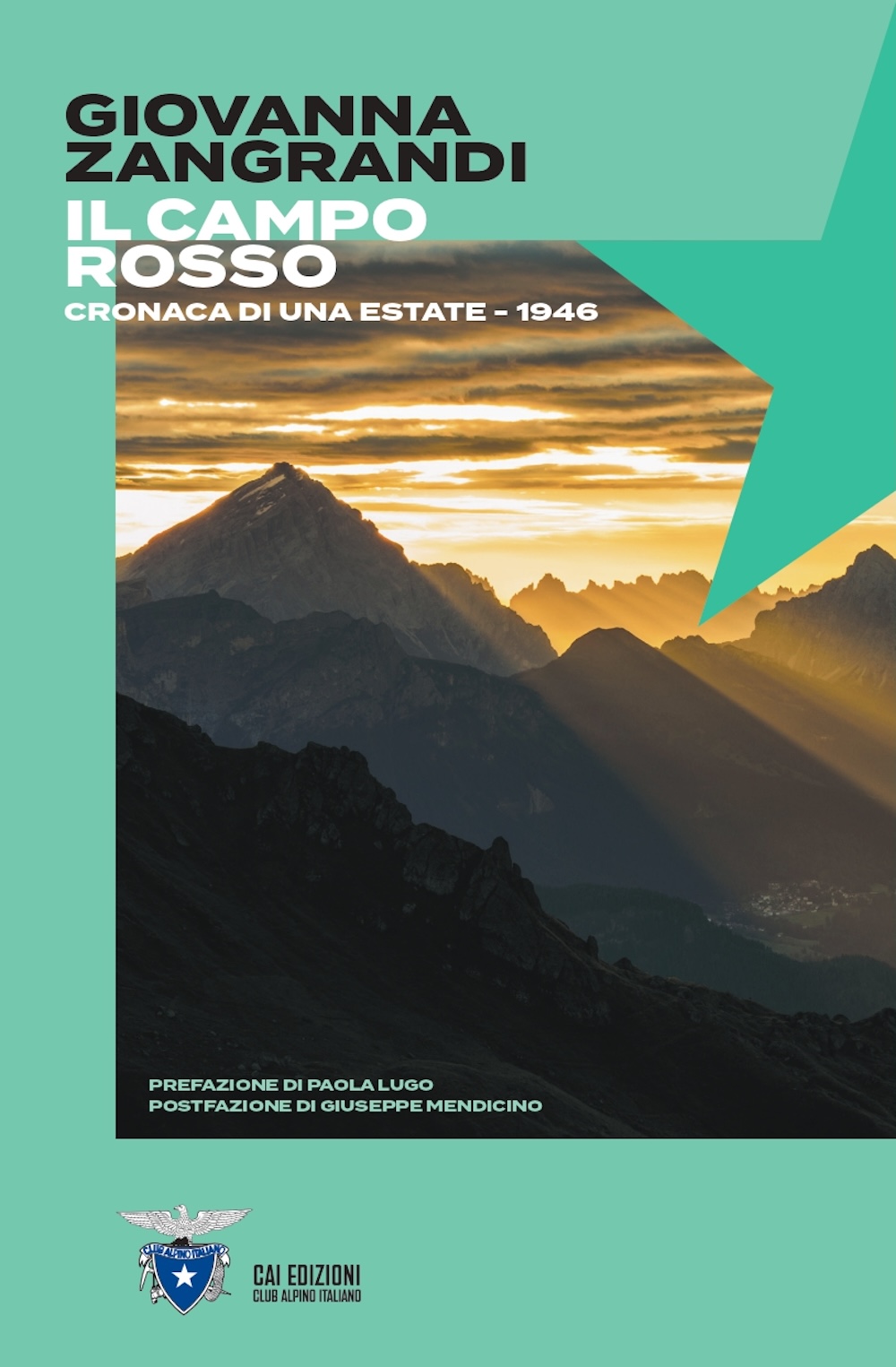 La copertina del libro di Giovanna Zangrandi, Il campo rosso, disponibile in tutte le librerie e su CAI Store.
La copertina del libro di Giovanna Zangrandi, Il campo rosso, disponibile in tutte le librerie e su CAI Store.