Alessandro Gogna non è solo un alpinista di spessore internazionale, ma con la sua scrittura negli anni ha avuto il merito di documentare e fare appassionare praticanti e non. Oggi il suo impegno è rivolto soprattutto a preservare l'idea di un alpinismo responsabile e rispettoso dell'ambiente. D'altronde, chi ha salito un mezzo migliaio di vie nuove nella sua vita può guardare con un certo distacco alle “diatribe da bar” che animano spesso l'universo arrampicatorio.
Quali sono i ricordi del tuo incontro con la montagna?
Ero in seconda elementare, avevo avuto un inverno difficile con bronchiti e polmoniti. Al tempo i dottori prescrivevano cure semplici…"bisogna portarlo in montagna". E così siamo andati a Bieno, in Valsugana, con mia madre e mia nonna. Ero emozionatissimo, feci tutto il viaggio con il naso all'insù, attaccato la finestrino del treno e della corriera. Un giorno, vicino al supermercato, c'era un tabellone dipinto a mano con indicati i sentieri della Sat. Ne rimasi affascinato. Andai a casa, presi carta e matite e me lo ricopiai. E da lì iniziai a esplorare le montagne, a capire che la montagna sarebbe stata la mia vita.
Solitario per vocazione o per necessità?
Per necessità. Nel 1954-55 non c'era il boom turistico, non c'era nemmeno l'idea. In Valsugana la gente faceva una vita grama, per me era difficile anche solo comprendere che si potesse mangiare polenta a colazione, pranzo e cena. Non sapevo che la vita fosse così dura, i miei coetanei spesso dovevano lavorare, altro che giocare o andare in giro. Avevano le loro fatiche quotidiane. Così mi muovevo principalmente da solo, anche perché per mio padre la montagna era raccolta funghi, per mia madre more e lamponi. Niente di male per carità, ma io cercavo altro.
 Dopo la salita alle Grandes Jorasses © archivio Gogna
Dopo la salita alle Grandes Jorasses © archivio Gogna
Come hai iniziato a scalare?
Ho iniziato nel '60, a 14 anni. Ho fatto le prime cose in Val di Fassa, vedevo gli alpinisti con le corde che andavano su, ho iniziato ad andare dietro a loro, volevo fare come loro. A Genova mi sono poi iscritto alla Sezione Ligure del Cai. Mi sono procurato la guida Palestre di arrampicamento genovesi (1963, edizioni Euro Montagna, ndr) e con i compagni di scuola abbiamo iniziato ad arrampicare anche qua.
Sei stato un frequentatore di Finale Ligure nei primi anni?
Non proprio dei primi anni. Alessandro Grillo aveva scoperto la Rocca di Perti nel 1972 (l'apertura della famosa via Il Vecchio è del 1973, ndr) quando ancora non c'era l'autostrada, che era in costruzione. Ma io mi ero trasferito a Milano nel 1969 e ho iniziato ad andare a Finale a partire dal 1974. Ho scalato anche con i vari Calcagno, Vaccari, ma per lo più scendevo con i milanesi, perché si partiva da Milano già con i compagni.
Ci sono ancora alcune tue relazioni sul mitico quaderno della Locanda del Rio, a Feglino, allora gestita dalla signora Angiolina. Oggi suo figlio, Gianni Bonora, lo custodisce con cura. È ricco di storie, scherzi...c'era un bel clima.
Noi la chiamavamo a scignôa…ci trattava bene, ci faceva anche dormire lì, dava da mangiare e da bere a tutti. Noi facevamo un gran casino, eravamo un gruppo piuttosto esuberante. Mi ricordo che una volta io e Marco Marantonio avevamo fatto una via nuova a Monte Cucco, lo avevamo scritto sul quadernone. Il mattino dopo c'erano a colazione Andrea Parodi e un suo amico, che si lamentava del fatto che gliela avessimo “fregata”. Alla domanda su chi fosse stato, la risposta fu “Gogna e il suo circo”, perché eravamo famosi appunto per il casino che facevamo. E allora cancellammo il vecchio nome e chiamammo quella via proprio Il circo. Erano anni in cui si stava già sperimentando un'arrampicata che andava al di là delle vecchie retoriche, con un approccio nuovo anche a livello di mentalità. Iniziava a vedersi una separazione tra l'alpinismo di montagna e la scalata in valle.
La prima solitaria della Via Cassin alle Grandes Jorasses rimane uno dei momenti più alti del tuo alpinismo?
Nel mio ricordo, la salita delle Jorasses rappresenta la perfezione se di perfezione si può parlare, nel senso che io personalmente più di così non potevo fare. È andato tutto molto bene, non solo per come ho fatto io, ma anche per la fortuna che ho avuto. È stata una piccola opera d'arte, che è riuscita anche perché le cose si sono incastrate perfettamente. Ci sono però anche altre cose che metto sullo stesso piano, per esempio la salita del Naso di Zmutt sul Cervino, dell'anno dopo. Lì non c'era stata solo la bravura o il coraggio, ma anche il fiuto di riuscire a battere un itinerario nuovo, il confronto con l'incognito.
 Sul Naso di Zmutt © archivio Gogna
Sul Naso di Zmutt © archivio Gogna
Sono due esempi di stato di grazia applicato all'alpinismo?
Sulle Jorasses sì, sul Naso quella sensazione è stata mitigata dal fatto che non ero solo ma con un compagno di cordata eccezionale (Leo Cerruti, ndr). Possiamo dire che la cordata era in uno stato di grazia, sì.
Ci sono vie poco significative ma che nel tempo hai rivalutato come esperienza personale?
All'inizio ho avuto fortuna in più di una occasione e quindi ho rivalutato certe esperienze. Per esempio, nell'estate del 1964 avevo fatto una “fracca” di salite e il primo settembre andai per fare la nord del Latemar. Si tratta di una parete cattivella per vari motivi, non tanto per la qualità della roccia, friabile, ma non clamorosa. Seguii la guida del Tanesini, che la indica di terzo grado, sui 700 metri. Avevo già scalato fino al V in solitaria, quindi mi sentivo a posto. Ma poi, a un certo punto la via finisce in un canalone e io avevo seguito alla lettera la relazione. Ma evidentemente non era stata percorsa, mi trovai a scalare in mezzo al ghiaccio e a un'intrusione di melafiro che si rompeva: una bella schifezza, per farla breve! Non sarà stato verticale, ma 70-80 gradi sì e riuscii ad andare avanti per qualche motivo che non so, probabilmente perché non avevo altra scelta. Fui bravo a tirarmene fuori.
A distanza di anni c'è qualcosa che non hai digerito? Vie che avresti voluto fare e non sei riuscito?
Rimpianti? Francamente no, non sono una persona che si guarda troppo indietro. Però le grosse spedizioni internazionali mi hanno lasciato più di un brutto ricordo. All'Annapurna volevamo fare lo sperone nord-ovest e abbiamo fatto l'errore enorme di fare il campo dove c'erano i francesi e sono morti due compagni, Cerutti e Rava. È stato terribile, quella cosa mi ha segnato per anni e non mi è mai passato per la testa di tornare per riprovare a fare l'ascensione. Anni dopo ci sono riusciti i polacchi. Sul Lhotse nel 1975 eravamo andati con una grande spedizione. A capo c'era Cassin. C'erano Messner e i migliori italiani, ma non siamo riusciti a scalare quella linea, che è ancora lì che aspetta. Per la prima salita sulla parete sud ci vollero comunque altri 15 anni. Avevamo avuto una visione, ma eravamo troppo avanti per il tempo. E poi il K2: stavo bene e non temevo la quota, gli effetti sul fisico, ma non è andata. Mi è scocciato molto non andare in cima, ma la spedizione è riuscita. Non c'è da avere troppi rimpianti.
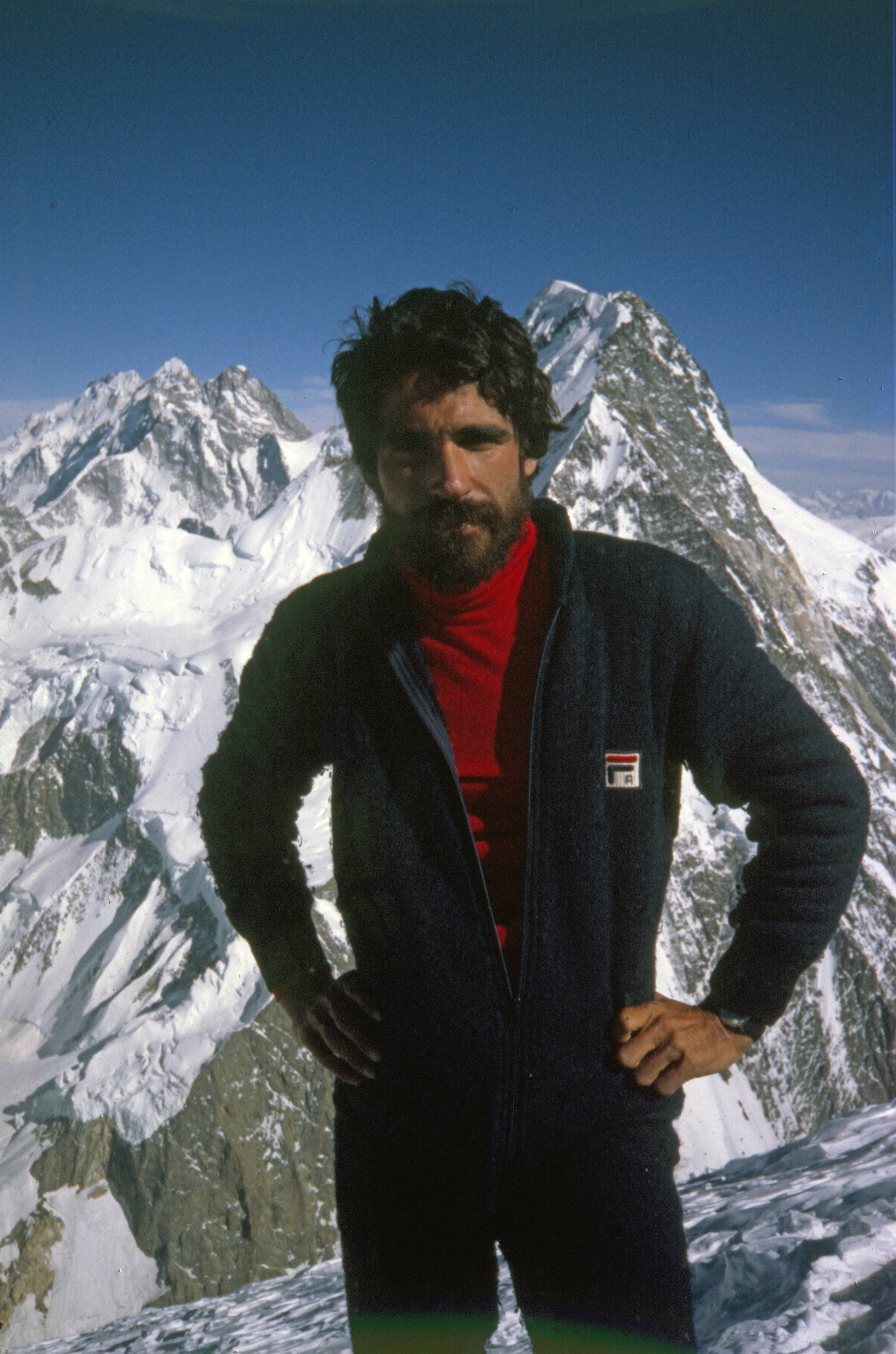 Al campo 3 del K2 © archivio Gogna
Al campo 3 del K2 © archivio Gogna
Al senato degli Stati Uniti recentemente è stato depositato un disegno di legge per limitare le nuove chiodature e regolamentare l'accesso alle zone d'arrampicata. Pensi che arriverà anche da noi qualcosa di simile?
Rientra in una di quelle cose che appunto vengono da oltreoceano: la mania della sicurezza che va a braccetto con la mania di trovare il responsabile anche quando il responsabile non c'è. È un disegno, o meglio una sorta di formazione culturale che sta arrivando anche da noi. Ma il limite alla libertà va cercato nei paletti che uno si mette da solo, è quello che fa capire che sei già responsabile e cresciuto. E non c'entra nulla se sei a un livello estremo o escursionistico. Il problema è che oggi c'è chi sovrastima le proprie capacità, una overconfidence che va insieme all'incapacità di pensare. La storia del cane a Punta Venezia è emblematica (un gruppo di persone è salito lungo un canalone innevato, il cane è precipitato e gli alpinisti sono stati soccorsi con l'elicottero, ndr). Invece che ragionare ci si porta dietro il telefono. L'indirizzo ormai è quello e noi dobbiamo difenderci da questo modo di intendere la montagna. Quando è successo il crollo della Marmolada il primo approccio è stato proibire. Ma per me non c'è niente da proibire. Se mi fossi trovato al posto di quelli che sono morti - tra l'altro due esperte guide alpine- non avrei fatto diversamente. È inutile agitarsi quando succedono cose di questo tipo, non serve andare oltre per cercare a tutti i costi di regolamentare quello che non si può.
Per quanto riguarda invece la lettera aperta di Larcher, Oviglia e Piola sulla tutela delle aperture dal basso?
In linea di massima viene da condividere la loro riflessione. È giusto che vengano condivise le modalità di apertura, utile per chi va a ripetere la via. Diciamo che non sarei stato l'ideatore di una lettera del genere, perché sono cose talmente ovvie che non ci sarebbe nemmeno da discutere a riguardo.