La montagna è thriller: con la sua capacità di dettare tempi e ritmi, i suoi silenzi, gli spazi immensi capaci di “spaurare” anche il cuore più indomito. Parola di Lorenzo Sartori, da martedì 18 giugno in libreria con Il Nido del Pettirosso (pp. 336, 18 euro, Fazi 2024): storia di una famiglia di Milano, genitori e due figlie di 12 e 15 anni, che si trasferisce in un paesino di montagna per gestire un albergo-ristorante, “Il Nido del Pettirosso”, appunto. Se Alveno esistesse, si troverebbe in Trentino, più precisamente in Val Rendena. Ma sogno e realtà non vanno d’accordo, proprio come successo davvero a un’amica cui ha rubato lo spunto per scrivere il libro. Da un lato la difficoltà di inserirsi in una comunità compatta, con le sue regole, le sue tradizioni, la sua storia, dall’altro alcune dinamiche relazionali fra i giovani del posto e le sorelle milanesi che sfuggono al controllo, consegnando le ragazzine nelle braccia di loschi individui incapaci di controllare i propri istinti. Una trama in cui la prima vittima è “Heidi”, ovvero lo stereotipo che dipinge la montagna come una cartolina, tanto bella quanto finta: la vicenda narrata rappresenta l’altra faccia del mantra “mollo tutto e cambio vita”, così in voga in epoca post-pandemica. E riecheggia lugubri fatti di cronaca accaduti in luoghi incantati che in passato hanno tenuto col fiato sospeso tutto il Paese, senza però indulgere nell’altro stereotipo delle comunità montanare grezze e chiuse, per non dire omertose.
Sartori, bresciano classe 1967, abita fra Crema e Milano: nel 2020, con Il filo sottile di Arianna (Laurana, 2021), ha vinto il prestigioso premio “NebbiaGialla” per i romanzi inediti, coronando un impegno nella scrittura durava da una decina di titoli, fra gialli, thriller e fantasy. Giornalista pubblicista e studioso di storia militare, è direttore artistico del festival letterario “Inchiostro”, che si tiene a Crema, e dal 2000 editore e direttore della rivista “Dadi&Piombo”. È considerato uno dei massimi divulgatori del “wargame”, giochi di simulazione di battaglie storiche.
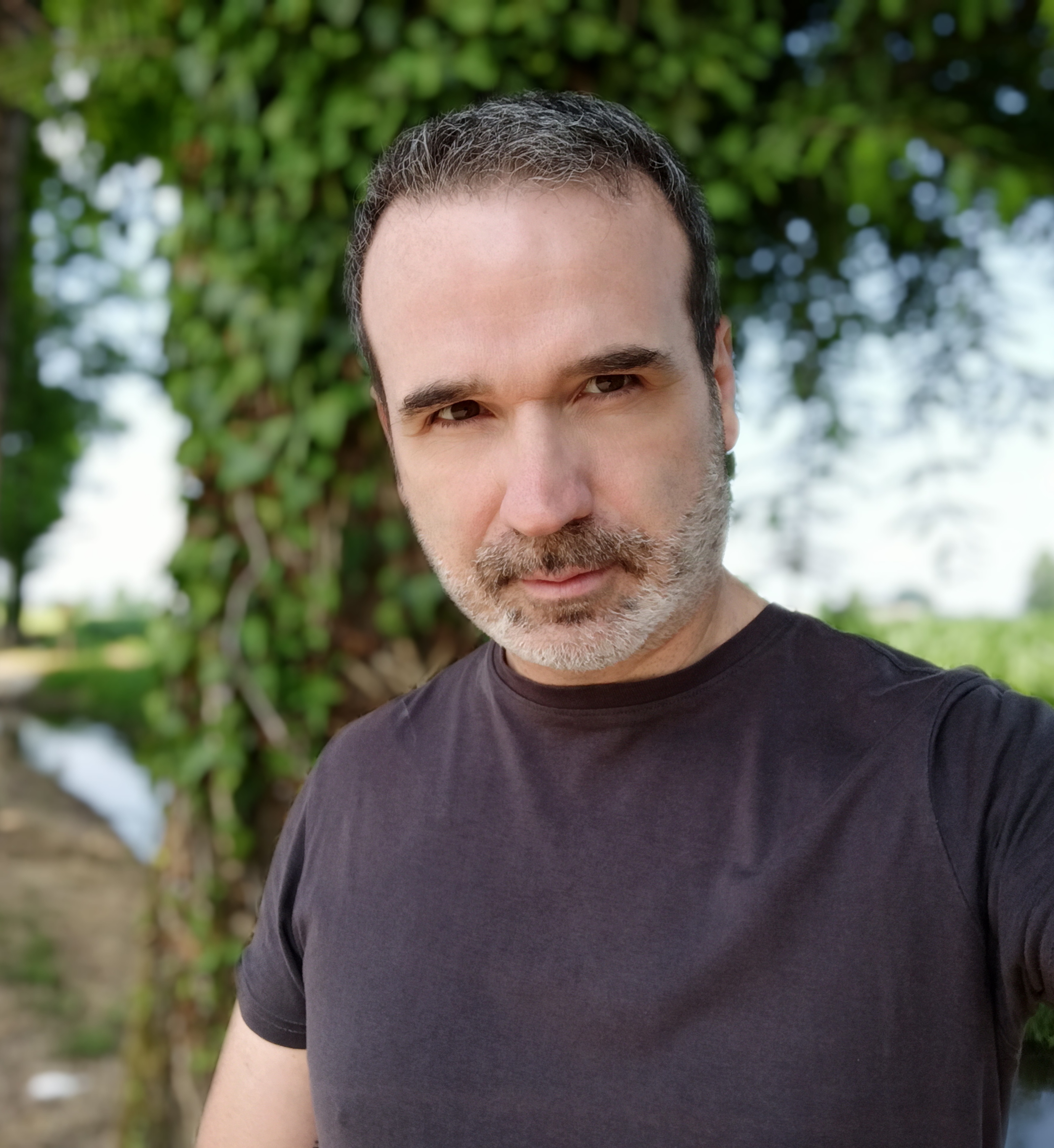 Lorenzo Sartori, foto dell'autore.
Lorenzo Sartori, foto dell'autore.Lorenzo Sartori, partiamo dalla fine, dove lei dichiara che la montagna è un luogo perfetto dove ambientare un thriller, come mai?
Per me è innanzitutto una questione di spazi e di tempi. L’ambientazione in città che caratterizza altri miei libri richiede molta precisione, nella toponomastica e nelle tempistiche di spostamento, poi si è comunque sempre in mezzo alla gente. In montagna invece sei faccia a faccia con la natura, ti puoi trovare completamente isolato, in un posto meraviglioso, ma in una situazione di inferiorità. E a differenza del mare, dove le storie che si narrano avvengono perlopiù sulla costa, in montagna ci sei dentro. E così anche i tempi possono essere dilatati e le dinamiche cambiare molto. Non a caso gli americani spesso ambientano thriller in posti isolati e fuori dal mondo, dove il primo centro abitato sta a 80 chilometri e uno sceriffo detta legge. Da loro se ne trovano molti di più che in Italia, dove l’unica è spostare l’azione in montagna, che è sempre bella per me da raccontare e da leggere. Tutti più o meno si trovano alle spalle un’esperienza in montagna.
Dove sta il bello della montagna?
Nei paesaggi spettacolari, nei suoi odori, nella sua varietà: puoi essere in vetta o sul limitare di un dirupo, o in un bosco, e anche i boschi non sono tutti uguali in base alle piante e alla stagione. E appunto, io nel libro parlo di una montagna estiva, ma in inverno è tutto un altro mondo. La montagna è una tavolozza di colori ed emozioni molto ampie.
Quanto conta l’ambientazione in un giallo?
Per me è fondamentale. La mia scrittura è molto cinematografica, ho bisogno di vedere le immagini che racconto, devo capire esattamente come si svolgono le scene, al costo di essere perfino didascalico. E quindi avevo sì in mente di ambientare un romanzo in montagna, ma è solo quando una mia amica mi ha parlato della sua esperienza di anni prima di trasferirsi lì senza però esserci cresciuta, che ho capito che quello era il punto di partenza. Era anche più facile per me identificarmi. Quando siamo andati sul posto, in Trentino, e mi ha mostrato l’albergo, che esiste ancora e ovviamente non si chiama “Il Nido del Pettirosso”, mi sono convinto. Ci siamo andati due volte (ma spero di tornarci ancora), prima del Covid, per questo la storia è ambientata nel 2019, e ho cercato di immaginarmi una famiglia di quattro persone che si trasferiva lì, come se ne fossi il quinto elemento silenzioso e invisibile, respirando la stessa aria, visitando gli stessi spazi, ipotizzando come si sarebbe potuto sentire un adolescente che arrivava lì dalla città…
Il luogo però è solo immaginario, anche se chiaramente siamo in Trentino e a un certo punto si cita la Val Rendena.
All’inizio non volevo fornire nessun tipo di dettaglio, per lasciare piena libertà al lettore di immaginarsi i luoghi. Qualche informazione in più l’ho fornita, ma prendendomi un po’ di libertà: le segherie veneziane (uno dei luoghi nevralgici dell’azione, NdR) in realtà si trovano in altre zone del Trentino, più verso il Parco dello Stelvio.
Il motore dell’azione sta nel desiderio di una donna, Laura, la madre delle due sorelle, di tornare a vivere nei luoghi dove è nata, ma dove poi non è cresciuta e che dunque non le appartengono più. La sua scelta è certo dettata anche da ragioni lavorative, ma il senso di appartenenza è uno dei temi forti del libro.
Io credo che noi apparteniamo ad alcuni luoghi e che alcuni luoghi appartengano a noi: c’è una reciprocità che non sempre possiamo decidere. Apparteniamo anche a luoghi da cui vogliamo scappare. O scopriamo in tarda età il luogo che avrebbe potuto ridefinirci come persone diverse, o perlomeno ci convinciamo che sia così senza aver avuto la possibilità di sperimentarlo… È il tema emerso scrivendo questo romanzo in cui, oltre alla trama thriller, mi piaceva descrivere una famiglia di quattro elementi dove ciascuno vive a suo modo lo spostamento, per qualcuno è uno sradicamento, per altri la speranza di trovare il proprio posto dell’anima, senza capire che è una fuga da se stessi. Non a caso una Alice (la sorella piccola, NdR) si chiama così, perché per lei questo è il “paese delle meraviglie”, con tutti i rischi connessi.
Molti protagonisti sono ragazzi e un altro tema sul piatto sono le opportunità che offre loro un posto piccolo e un po’ isolato come un paesino di montagna, non solo lavorative.
Io non ho mai vissuto in montagna, ma mia mamma è di Tremosine, quindi da adolescente ho passato molte estati dai miei nonni sul Lago di Garda, in zona collinare. Pur essendo quello un posto turistico, so cosa vuol dire sperare che qualcuno abbia la macchina per andare dove c’è un minimo di vita. La montagna è un posto più difficile per i giovani, che di solito iniziano a lavorare presto e diventano adulti in fretta, se non hanno la possibilità di proseguire con gli studi, spostandosi però a vivere in un centro più grande. Come succede anche al mare o su un’isola. Il turismo apre certamente delle porte in più, ma la vita rimane più dura, con meno distrazioni e stimoli che invece una città può dare.
Però le città stanno perdendo molto, da questo punto di vista, non sono più così appetibili per qualità di vita…
In effetti, difficilmente chi vuole cambiare vita sogna di trasferirsi in città… Forse i giovani, per quello che offre anche lavorativamente.
Ci sono due elementi che fanno capolino: gli orsi e gli immigrati, simboli del diverso per antonomasia. Sono solo funzionali alla trama?
Gli orsi sicuramente caratterizzano il Trentino, in più mentre scrivevo il libro se ne parlava molto (l’uccisione di Andrea Papi da parte di un orso risale ad aprile 2023, NdR). Ho molto riflettuto se inserire o meno questo elemento, alla fine ho deciso di sì, ma restituendone almeno la complessità: Alice, che scopre l’orso, prima ne ha paura, poi però, quando vede tutti quei cacciatori pronti a ucciderlo, tifa per lui. Mentre gli immigrati ci sono per far capire che nemmeno nella montagna più sperduta siamo isolati dal mondo e dai problemi della contemporaneità.
Nella trama si insinua anche la grande storia: c’entra qualcosa la tua passione di inventare giochi di simulazione?
Io scrivo per una rivista specializzata di sistemi di gioco che consentono di ricostruire battaglie coi soldatini, rigiocando in miniatura quelle di Alessandro Magno o di Napoleone. Per divertirsi, ma anche per capire come avvenivano le battaglie in quelle epoche. Ha a che fare con il collezionismo, con il gioco e con la simulazione di strategie. Parlare di storia mi è servito a far capire che ci sono luoghi che ne hanno viste tante e continueranno a vederle, indipendentemente dagli uomini che li attraversano.
Quali sono gli scrittori a cui ti ispiri?
Io leggo di tutto, ma ci sono autori con cui mi sento più in sintonia e da cui imparare qualcosa. Philip Roth e McEwan sono inarrivabili per me, per scrittura e approccio, a Joe Lansdale mi ispiro molto. E spesso lui, come e più di Stephen King, ha per protagonisti ragazzi e adolescenti. La ricerca dell’identità è un tema che amo, anche in questo romanzo è molto presente, e i giovani ne sono una perfetta chiave di accesso, perché con loro puoi riflettere sulla perdita dell’innocenza e su tutto quello che puoi ancora diventare.
Cosa è necessario in un thriller?
Scrivere thriller è la mia vocazione, ma non è facile rispondere. Bisogna creare una tensione continua, non necessariamente una tensione “nera”. Adoro i colpi di scena, quando le cose si rivelano diverse da come sono, è il motivo per cui leggo e scrivo thriller. Ci deve essere ritmo e bisogna far leva sulle paure, che non sono solo quelle della cronaca nera.
Di quali paure parli?
Ci sono paure su cui in fondo si pensa di poter agire. Altre che non si vogliono proprio affrontare, di queste non riesco a scrivere, forse perché mi fanno davvero paura. La paura del fallimento, incarnata dal personaggio di Laura, è tipica dei nostri tempi, perché viviamo in una società che ci vuole sempre al massimo.
Secondo te ha a che fare con la perdita di connessione fra uomo e natura?
Solo davanti alla natura capisci te stesso. Chi fugge dalla città non ha solo bisogno di andare in un posto sperduto, ma di scappare dal rumore generato dagli altri, fatto a volte da aspettative. La natura, invece, con il suo silenzio ti restituisce per quello che sei, ti consente di riflettere, come uno specchio. Per questo sono andato a fare il sopralluogo, a casa non avrei potuto davvero pensare la mia storia, invece là in un paio di ore ce l’avevo tutta in mente. Il problema che abbiamo con la natura è che noi ci mettiamo sempre troppo al centro, sempre in lotta con gli altri. Di fronte a un paesaggio maestoso tutto si ridimensiona, l’uomo non è più il vertice del Pianeta, ma un piccolo elemento, e finalmente l’ego lascia spazio all’io.