 Una marmotta si scalda al sole d'estate. Pixabay.
Una marmotta si scalda al sole d'estate. Pixabay.Nel cuore delle Alpi, tra le vette del Parco Nazionale dello Stelvio, si aggira un piccolo roditore che da secoli cattura l’immaginazione di scienziati e abitanti locali: la marmotta alpina. Con il suo fischio acuto e la vita sociale complessa, questo animale è diventato simbolo delle montagne e sentinella degli ecosistemi d’alta quota.
Il libro Dialoghi di montagna: la marmotta tra ricerca e saperi antichi di Sabina Colturi (pp. 112, 10 euro, EdiNat 2025) ci invita a esplorarne il mondo, intrecciando le più recenti scoperte scientifiche con le tradizioni e le leggende che lo circondano. Un’opera che ci ricorda quanto sia prezioso il dialogo tra sapere accademico e conoscenza popolare.
E proprio ora che arriva la primavera e torneremo a sentire quel fischio così inconfondibile, è tempo di ascoltarlo davvero e farci guidare nella conoscenza di questo animale, per imparare la complessità degli ecosistemi montani e maturare un maggiore consapevolezza nel frequentarli.
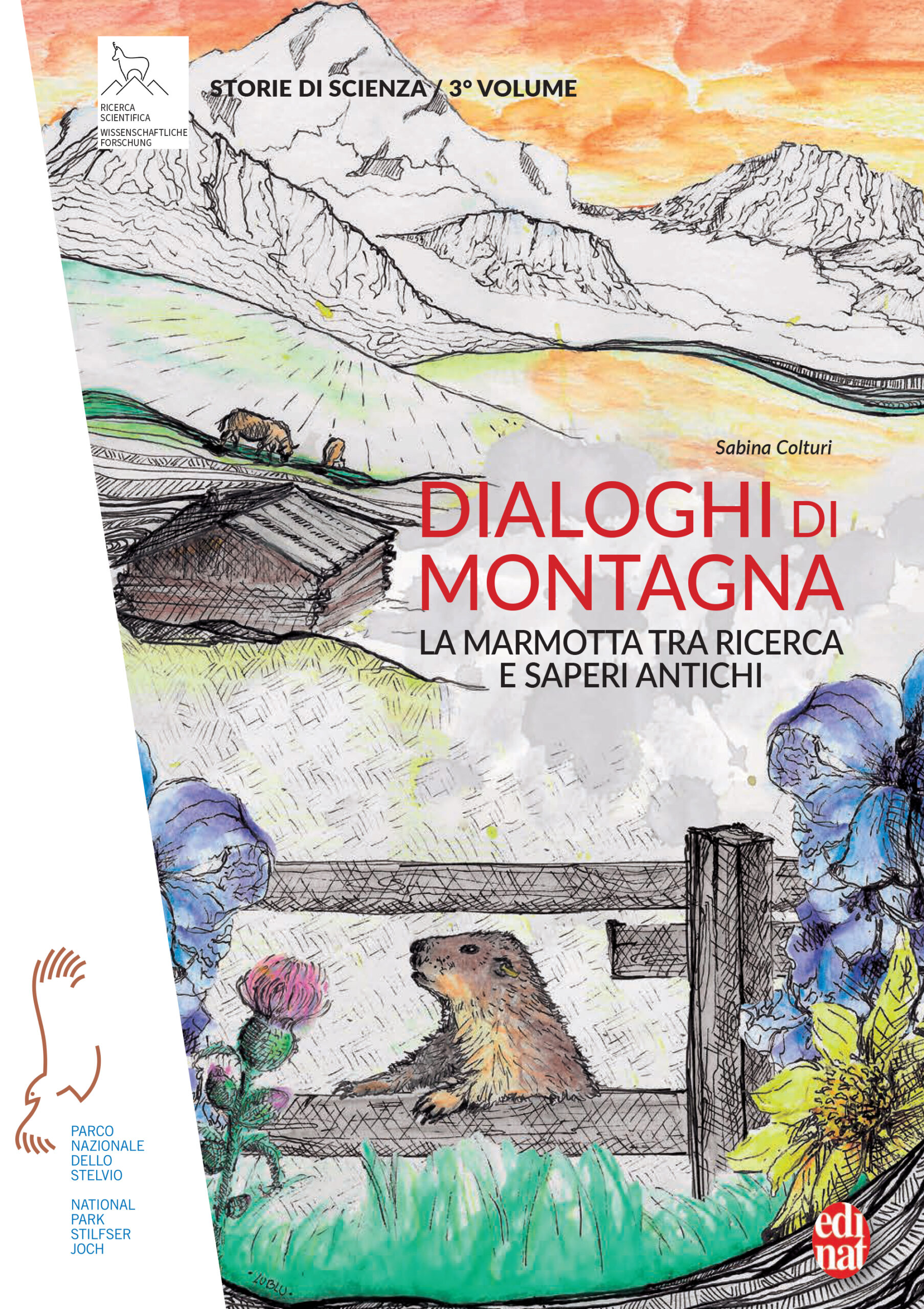 La copertina del libro.
La copertina del libro.Il libro
L’opera della biologa Sabina Colturi è frutto di un intenso lavoro di scambio e confronto portato avanti con il gruppo di ricerca e di comunicazione che opera all’interno dell’area protetta, in particolare Anna Sustersic, Elena Morocutti e Chiara Giari, impreziosito da un importante supporto infografico e dalle illustrazioni di Lucia Gerber.
Nel suo impianto generale, il libro esalta l’importanza di uno scambio continuo fra studiosi e abitanti delle terre alte, custodi di una conoscenza popolare insostituibile: ne risulta un ben riuscito equilibrio tra le interviste ai ricercatori e i racconti di chi la montagna la vive da generazioni. L’opera è divisa in sezioni che toccano diversi aspetti della marmotta alpina: biologia, comportamenti, habitat, percezione culturale.
Centrale è lo studio del Parco Nazionale dello Stelvio, avviato nel 2014 e ancora in corso, che si inserisce all’interno del progetto Wildlife Observation and Awareness. In più di dieci anni, l’osservazione delle colonie di marmotte ha permesso di raccogliere dati dettagliati su abitudini alimentari, dinamiche di gruppo, rapporti con i predatori e tempi di ibernazione.
Un focus importante è sul ruolo della marmotta come “sentinella del cambiamento climatico”: modifiche nei tempi di emersione primaverile, riduzione del periodo di letargo e alterazioni del comportamento sociale sono segnali chiave per leggere l’impatto del riscaldamento globale sugli ecosistemi alpini.
Il libro dà spazio anche alla voce dei pastori, delle guide alpine, degli abitanti delle valli: saperi antichi che riconoscono nella marmotta un animale totemico, a volte portafortuna, altre presagio. Le storie raccontano di marmotte che “parlano” al paesaggio, che indicano il tempo, che segnalano la presenza dell’uomo. Il testo si muove così in un registro narrativo che affianca rigore scientifico e immaginario collettivo.
L’autrice
Sabina Colturi, biologa e referente per le attività didattiche del Parco, è una giornalista e divulgatrice culturale con alle spalle una lunga esperienza nel raccontare il territorio alpino. Vive e lavora in Valtellina, da anni si occupa di narrazione del paesaggio e valorizzazione del patrimonio montano. Ha collaborato con istituzioni come il Parco dello Stelvio, ERSAF e varie realtà culturali della Lombardia.
La sua scrittura si distingue per un approccio che mette in dialogo linguaggi diversi: accademico, divulgativo, orale. Colturi non si limita a documentare: ascolta, rielabora, costruisce ponti tra il sapere degli scienziati e quello delle comunità locali. Questo metodo emerge con chiarezza anche in Dialoghi di montagna, che non è una semplice raccolta di dati o interviste, ma un esperimento narrativo a più voci. L’autrice dimostra un talento particolare nel far emergere l’anima dei luoghi attraverso gli animali che li abitano.
La collana del Parco Nazionale dello Stelvio
Il volume fa parte della collana editoriale Storie di scienza, nata all’interno del Parco Nazionale dello Stelvio in collaborazione con ERSAF Lombardia e coordinata da Anna Sustersic (di cui in maggio uscirà per CAI Edizioni il volume Relazioni naturali, dedicato alla coesistenza fra uomini e animali, tema che l’autrice triestina studia e divulga da anni). Si tratta di un progetto culturale che punta a raccontare la biodiversità alpina in una forma nuova, accessibile, mai banale. Ogni titolo è dedicato a una “figura del paesaggio”, con l’intento di restituirne complessità ecologica e risonanza culturale. Prima della marmotta, la collana ha ospitato volumi dedicati alla vipera, al gallo cedrone, alla rana temporaria: animali poco “mediatici”, ma essenziali nella rete ecologica dell’arco alpino. L’idea è raccontare ciò che spesso rimane invisibile, ma tiene in piedi l’equilibrio naturale. Ogni pubblicazione è frutto di un lavoro corale tra biologi, guardiaparco, ricercatori, grafici, scrittori.
Il Parco Nazionale dello Stelvio, tra i più estesi d’Europa, si conferma così non solo come presidio ambientale, ma anche come laboratorio culturale e luogo di sperimentazione editoriale. La sua attività scientifica, come nel caso del progetto marmotta, si intreccia con la volontà di rendere la natura un bene condiviso anche sul piano narrativo.
In questo contesto, Dialoghi di montagna si distingue per lo stile: sobrio, evocativo, mai retorico. Il formato agile, il linguaggio curato ma accessibile, le illustrazioni e le fotografie originali lo rendono uno strumento perfetto per scuole, appassionati, escursionisti e lettori curiosi. È un libro che si può leggere in cammino o accanto al camino, che invita a guardare la marmotta – e, per estensione, la montagna – con occhi nuovi.