 Giovanni Di Vecchia, Dante Colli e Marco Blatto al Museo Nazionale della Montagna di Torino © Archivio Gism
Giovanni Di Vecchia, Dante Colli e Marco Blatto al Museo Nazionale della Montagna di Torino © Archivio GismIl Gruppo Italiano Scrittori di Montagna si avvia verso i 100 di storia, guardando al passato ma anche al futuro. Marco Blatto, classe 1965, ne è presidente dal 2022. Geografo, scrittore e alpinista attivo, Blatto è stato uno dei maggiori protagonisti dell’alpinismo sulle Alpi Graie Meridionali, promuovendo in alta montagna uno stile classico e senza facilitazioni tecnologiche. E’ Membre Actif del Groupe de Haute Montagne francese (GHM), Full Member dell’Alpine Club di Londra e dell’Alpine Climbing Group (ACG). E’ membro della Commissione Centrale Cai Cultura e direttore del Centro di Documentazione Alpina “Luigi Vaccarone” di Cantoira, in Val Grande di Lanzo. Con lui partiamo dall'inizio.
Come, quando e perché nasce il Gism e com’è stata la sua evoluzione in questi quasi 100 anni?
Il Gruppo italiano scrittori di montagna nasce in un particolare momento storico della vita sociale e politica italiana. E l’aprile del 1929 quando Augusto Turati assume la presidenza del Club Alpino Italiano, la cui sede è trasferita da Torino a Roma. L’alpinismo è inquadrato nel Coni e nello sport fascista, una nuova condizione che trova l’avversione di molti alpinisti e intellettuali, che ritengono che l’andare per monti, con mezzi tecnici o senza, sia un’attività con caratteri etici ed ideali. Se da un lato, dunque, il Club Alpino Accademico Italiano, per sua natura “tecnica” accetta senza questioni questo incorporamento dell’alpinismo nel Coni, dall’altro si pensa di esercitare una qualche forma di opposizione intellettuale.
Agostino Ferrari, medico, alpinista e scrittore torinese, propose così all’amico Adolfo Balliano la costituzione di un gruppo di scrittori - alpinisti, che fosse una specie di contraltare dell’”Accademico”. Un’iniziativa che, seppure apparentemente politicamente innocua portò nel suo atto costitutivo tutta la sua avversione alle scelte del regime. Balliano era direttore della rivista il “Monviso” e, proprio nel 1929, aveva iniziato a pubblicare il periodico “Alpinismo”. Aveva un’idea di alpinismo come espressione artistica più che sportiva, dunque abbracciò subito l’idea di Ferrari. In verità furono molti gli alpinisti che accolsero l’invito dei due amici e nel nucleo primigenio troviamo così Guido Rey, S.A.R. Luigi Amedeo il Duca degli Abruzzi, Giovanni Bobba, Ugo De Amicis. Che il neonato gruppo fosse davvero un contraltare dell’Accademico è chiaramente raccontato dal suo simbolo, che diventò il distintivo di cui si fregiarono i soci. Esso richiamava chiaramente a quello del gotha degli alpinisti del Club Alpino: la piccozza, però, fu girata con la becca nel senso opposto, la corda che cinge lo scudo tondeggiante, sostituita dall’alloro dell’Accademia culturale e, infine, la stella da un libro aperto. Anche nel Gism l’ammissione doveva essere supportata da un’esaustiva attività alpina cui doveva affiancarsi quella culturale, di scrittura, di pittura o comunque artistica. Non mancarono le frecciate al neonato gruppo accademico di Adolfo Hess e i battibecchi tra le due realtà ma, il Gism, fin da subito poté beneficiare di una condizione unica: l’indipendenza dal CAI e una certa libertà d’espressione, caratteristica che vige ancor oggi. Ferrari che del Gism fu fiduciario scomparve precocemente, così la prima presidenza toccò all’amico e cofondatore Adolfo Balliano. Il gruppo nel tempo ampliò le sue fila e nel tempo vi passeranno alcuni dei più grandi nomi dell’alpinismo, molti dei quali Accademici del CAI e guide alpine, oltre che esponenti della letteratura e della cultura di montagna. Ricordiamo, fra tutti, Angelo Abrate, Ettore Zapparoli, Bruno Toniolo, Severino Casara, Felix Germain, Piero Ghiglione, Ettore Castiglioni, Riccardo Cassin, Mario Fantin, Fosco Maraini, Alberto Maria De Agostini, Irene Affentrangher, Armando Aste, Bianca di Beaco, Rolly Marchi, Dino Buzzati, Bepi De Marzi, Cesare Maestri, Gian Carlo Grassi, Cosimo Zappelli, Oreste Forno, Mauro Corona, Manrico Dall’Agnola, Alessandro Gogna, Gianni Battimelli. Ne assunsero la presidenza, dopo Adolfo Balliano, Francesco Cavazzani, Salvator Gotta, Giulio Bedeschi, Spiro Dalla Porta Xydias, Dante Colli e, infine, il sottoscritto.
 Andrea Gabrieli, Dante Colli, Cristhian Roccati, Spiro dalla Porta Xydias, Piero Carlesi e Irene Affentranger a Finale Ligure nel 2015
Andrea Gabrieli, Dante Colli, Cristhian Roccati, Spiro dalla Porta Xydias, Piero Carlesi e Irene Affentranger a Finale Ligure nel 2015Da chi è composto il Gism e cosa fa?
Oggi il Gism mantiene fede agli scopi e alle visioni dei padri fondatori, ammettendo tra le sue fila tutti quelli che hanno fatto dell’alpe una ragione di vita e dell’alpinismo un modo per esprimere un proprio sentimento artistico e ideale. Nel corso di quasi un secolo di vita, il sodalizio ha aperto a tutte le forme di espressione e di narrazione della montagna: letteratura, scienze, arti figurative e cinematografia. Una particolare attenzione è riservata anche alle nuove forme di comunicazione, come per esempio il mondo dei blogger e dei web journal. Il Gism rimane pur sempre un gruppo accademico, ed è importante rimarcare che occorre essere presentati da due soci accademici e avere un curriculum di un certo peso, sufficientemente documentato. La possibilità di avere soci che siano alpinisti attivi, scrittori, scienziati, videomaker, artisti, ci permette di costituire una voce unica e autorevole che può fornire un contributo d’eccellenza in ogni evento o manifestazione culturale legata alla montagna. Potrei azzardare che l’ammissione al Gism, costituisce un po’ una sorta di laurea honoris causa in cultura alpina.
Quali sono le parole "simbolo" che esprimono al meglio il Gism?
Sono molte, ma ne scelgo due: “ideale” ed “etica”, strettamente interconnesse e che costituiscono l’impalcatura del Manifesto Etico della Montagna che abbiamo presentato al Palamonti di Bergamo in occasione della nostra assemblea nazionale, nel giugno del 2022. L’ideale, come già in parte spiegato, è ciò che caratterizza il nostro essere alpinisti e frequentatori della montagna. Riteniamo, infatti, che l’alpinismo non possa essere considerato esclusivamente uno sport, ma che la sua essenza abbia una forte connotazione “spirituale”. Come giustamente sosteneva il nostro amato Past President Spiro Dalla Porta Xydias: “L’arte eleva soltanto lo spirito, mentre l’alpinismo eleva anche il corpo”. Una semplice dimostrazione di questa natura filosofica e spirituale è data dal fatto che l’alpinismo, unico tra gli sport, in poco più di duecento anni di vita ha prodotto forme di espressione artistica che vanno dal recit d’ascension, al romanzo, alla poesia, alle arti figurative. Se vogliamo, questa condizione lo pone già entro una dimensione etica unica, che è molto importante, specialmente oggi, nel considerare l’alpinismo come un mezzo d’espressione, ma affermando la centralità della montagna con o senza la presenza dell’uomo. Una montagna che non può essere considerata come un impianto sportivo o un teatro d’azione privo d’ogni empatia. Nel nostro manifesto sosteniamo l’importanza di un alpinismo che non sia sottoposto alla deità del tecnicismo, spesso invasivo e svilente, ma che sia improntato sull’adattamento dell’uomo all’ambiente con cui si misura. Sosteniamo perciò le aperture in un’ottica “pulita”, senza eccesso di mezzi tecnici e lo stile alpino nel grande alpinismo extraeuropeo. La dimensione etica che promuoviamo non abbraccia soltanto la scalata ma tutta la frequentazione della montagna e le politiche di sviluppo turistico. Oggi più che mai, in un’epoca di rapida trasformazione delle terre alte per effetto dei cambiamenti climatici, con forte impatto sulla biodiversità, le scelte etiche sono di vitale importanza.
Un’altra parola “chiave”, direttamente legata alla questione etica è: “libertà”. Un tema piuttosto sentito dagli alpinisti che fanno delle scelte consapevoli, ma incompreso dall’opinione pubblica che oggi, grazie ai social media, si nutre di tutto ciò che attiene la montagna intervenendo con severo giudizio critico, senza avere i necessari strumenti culturali. Basti vedere ciò che accade quando, in seguito a interventi di soccorso a principianti o praticanti non sufficientemente preparati, si scatena un’ondata d’opinioni che di “etico” e anche di utile non hanno assolutamente nulla. Complice anche un’informazione sempre più alla ricerca del sensazionale, si richiedono a gran voce regole, divieti, sanzioni, patentini obbligatori. Il grande nemico della montagna oggi è l’errore, che a detta di molti va trattato con strumenti repressivi. Noi alla “norma” opponiamo la consapevolezza, difendendo la montagna come uno degli ultimi spazi di libertà rimasti. Promuoviamo il valore del senso del limite e dell’educazione contro vaghe linee guida e procedure che tentano sempre di più d’inquadrare l’alpinismo e l’esperienza in montagna.
Quali sono le prospettive e i progetti per il presente e soprattutto per il futuro?
Credo di poter affermare che dall’insediamento del nuovo consiglio e dall’inizio della mia presidenza, nel settembre del 2022, pur nel segno della tradizione e dei valori ideali il Gism abbia fatto dei grandi passi avanti, verso il presente e verso il futuro. Dopo un periodo piuttosto lungo caratterizzato dall’autoreferenzialità e dalla difficoltà d’inserirsi a pieno titolo nel dibattito alpinistico e culturale della montagna contemporaneo, anche per un’età media piuttosto elevata dei consiglieri, abbiamo operato uno svecchiamento della struttura operativa e delle idee. Questo passo coraggioso, non sempre compreso dai soci più anziani, è anche merito del Past President Dante Colli, che ha maturato la necessità di cedere il passo a energie nuove. Per quanto mi riguarda, ho voluto che nel consiglio fossero rappresentate un po’ tutte le anime della montagna, dalle scienze naturali, all’alpinismo accademico, alla letteratura, alle scienze storiche e sociali, per giungere al più giovane mondo dei blogger. Una scelta che ha pagato in termini di attrattività e se da un lato abbiamo perso qualche socio più conservatore, dall’altro abbiamo acquisito molti giovani impegnati non solo nell’alpinismo, ma anche nella divulgazione. In particolar modo videomaker e cineasti. Se vogliamo essere attrattivi per i giovani e garantire un ricambio generazionale più rapido di quanto non sia stato fatto in passato, dobbiamo saper stare nel presente con un piede nel futuro.
Credo che le nostre sfide siano ben rappresentate nei punti del “Manifesto Etico della Montagna”. Saremo presenti il più possibile con i nostri soci accademici ai festival, alle rassegne, agli appuntamenti importanti della montagna, dove si fa cultura. Per esempio, anche quest’anno promuoveremo un convegno al “Trento Film Festival”, con un tema di grande attualità e con relatori importanti. Patrocineremo importanti rassegne e premi della montagna nazionali e rilanceremo, come accade annualmente, il Premio d’Alpinismo e Cultura “Spiro Dalla Porta Xydias”. Si tratta di un riconoscimento destinato a un’alpinista la cui attività di alto livello, che si sia espressa il più possibile entro una dimensione etica, sia stata accompagnata da intenti artistici e divulgativi. Poi, siamo in vista dell’importante centenario del 2029, per cui stiamo già lavorando attivamente. Da non dimenticare la realizzazione dell’annuario “Montagna”, che secondo me rappresenta attualmente la più bella rivista di cultura alpina italiana, per contenuti e autorevolezza delle firme.
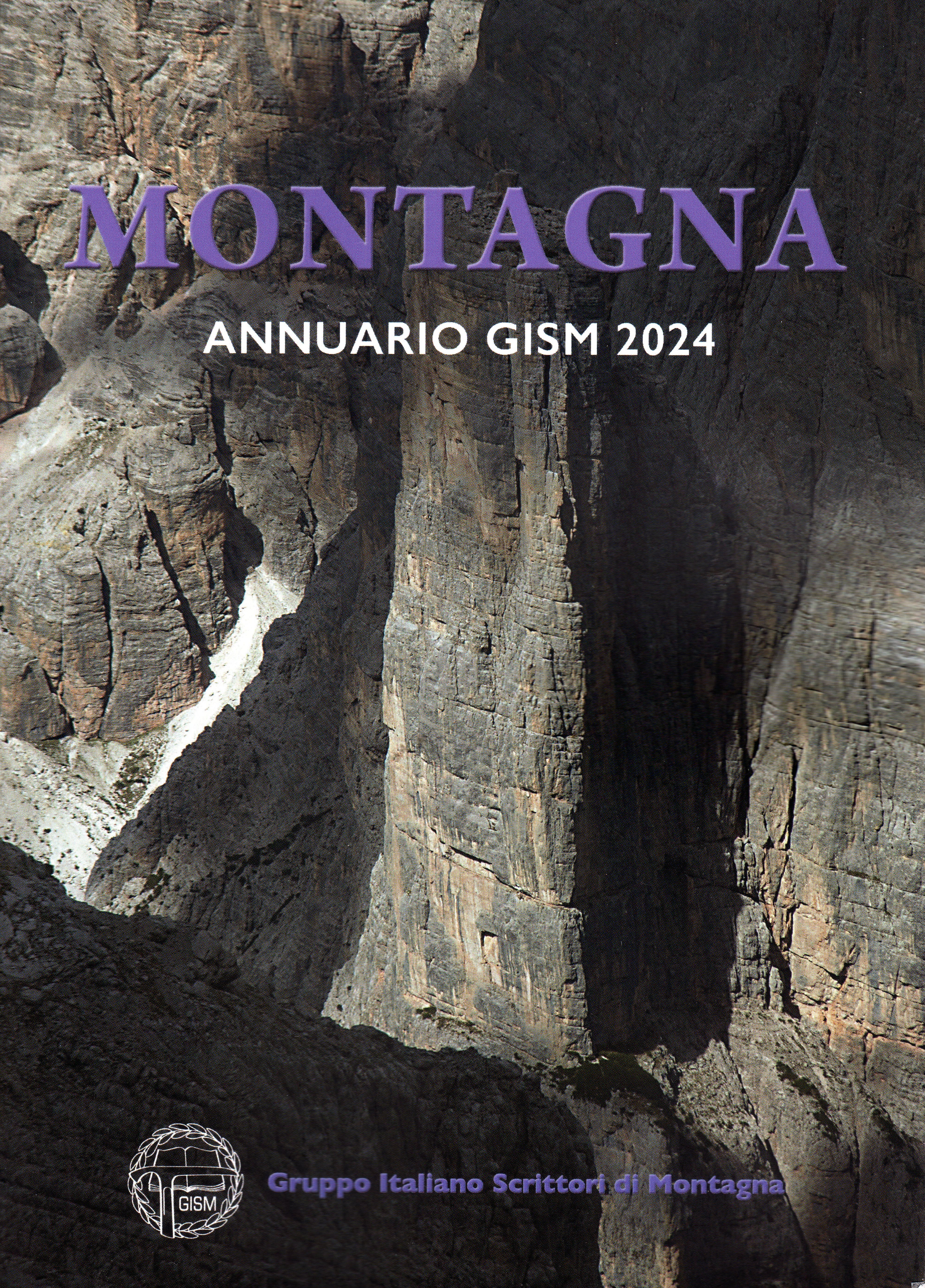 Una copertina dell'annuario del GIsm
Una copertina dell'annuario del GIsm