La mattina del 20 agosto 1980 sulla cima della montagna mitica, l’Everest, si posa lo scarpone di Reinhold Messner. L’impresa, la prima in solitaria e senza ossigeno, abbatte l’idea di impossibile per la specie umana. Messner, respirando l’aria rarefatta del tetto del mondo, inspira anche anidride carbonica e per la precisione ne respira 339 parti per milione.
Sono passati pochi mesi dal memo inviato alla Casa Bianca sugli effetti di massicce dosi di CO2 in atmosfera (finiva proprio qui lo scorso articolo). Un anno dopo l’impresa di Messner, il Club Alpino si riunisce a Brescia per stilare il primo Bidecalogo, un “documento programmatico per la protezione della natura alpina”: venti regole che il Club Alpino si impegna a rispettare in materia di ambiente, alpinismo, turismo. Il primo approccio politico del CAI all’ambiente è un documento cauto: si parla di limitare, ragionare, studiare, scoraggiare. È un documento cauto ma al contempo bello: ci si legge il periodo storico in cui fu scritto.
Sono gli anni ‘80, non si parla ancora di gas climalteranti, gli inverni sono nevosi e consentono di sviluppare un’industria dello sci che solleva le sorti economiche di molte valli e di molte comunità montane. Una nuova idea di turismo fa breccia nel BelPaese: è il decennio della settimana bianca, del “ski, sex and sun”.
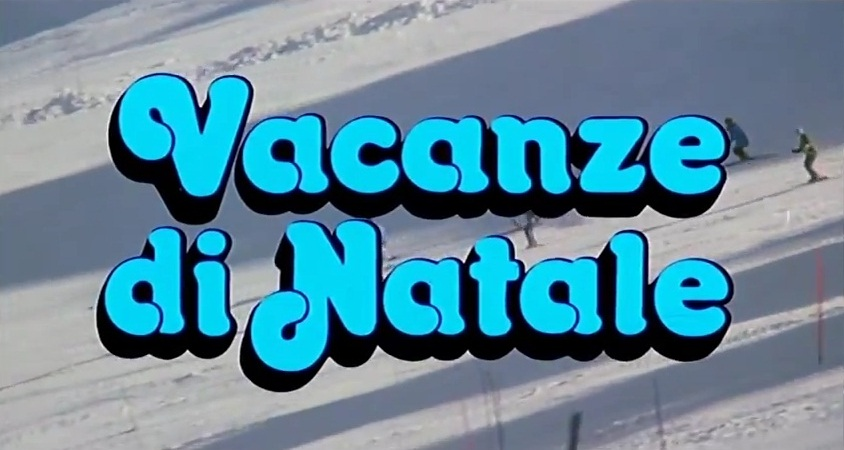 Screenshot del titolo del film Vacanze di Natale di Carlo Vanzina (1983)
Screenshot del titolo del film Vacanze di Natale di Carlo Vanzina (1983)In totale contrapposizione al turismo mordi e fuggi nello stesso decennio, precisamente nel 1986, Stefano Ardito tramite le pagine di “Repubblica”, sogna un “Gran Sentiero Italia”, un sentiero a lunga percorrenza che attraversa lo stivale. Pochi anni dopo, nel 1990, la Commissione Centrale Escursionismo inizia a lavorare sulla realizzazione del "Sentiero Italia”, simbolo di una corretta fruizione del territorio e della montagna. Sopra i sentieri che pian piano delineano il nuovo progetto sentieristico nazionale fremono 354 ppm di CO2. Abbiamo appena superato la soglia di sicurezza per il riscaldamento globale (350 ppm, secondo la comunità scientifica): sopra questa concentrazione, gli effetti negativi del cambiamento climatico diventano più pronunciati e difficili da gestire. Noi ce ne accorgeremo solo con lo scorrere del tempo.
.jpg) "80's Ski Wear" by pdbreen is licensed under CC BY 2.0.
"80's Ski Wear" by pdbreen is licensed under CC BY 2.0.Le parole di Gregory Bateson “Io credo che questa massiccia congerie di minacce all’uomo e ai suoi sistemi ecologici sorga da errori nelle nostre abitudini di pensiero” aprono il 94° Congresso del CAI a Verona del 1990, che culmina con la sottoscrizione della Charta di Verona, un vero “mea culpa” del Club Alpino per aver disatteso il proprio Bidecalogo in questo ultimo decennio e di aver assistito in modo quasi passivo ad un vero a proprio assalto alle Alpi. Con questa Charta la tutela dell’ambiente alpino e della montagna devono tornare centrali nelle attività del CAI: si tratta della prima vera e propria virata ambientalista (nel termine di tutela dell'ambiente) del sodalizio.
L’arrivo del nuovo millennio (e il sollievo di essere sopravvissuti incolumi al Millenium Bug) porta con sé un rinnovato entusiasmo per le spedizioni dell’alpinismo classico sui grandi giganti: dal Cho Oyu, passando dal Makalu, fino all’Annapurna. Nel 50esimo anniversario della prima conquista del K2 vengono ripercorsi i passi di Ardito Desio e per l’occorrenza il Club Alpino installa un mini-inceneritore al Campo Base della spedizione. Un primo timido passo verso l’annosa questione dell’accumulo dei rifiuti in quota. Pochi decenni dopo (ossia qualche giorno fa per noi che leggiamo questo articolo) troveremo il Campo IV dell’Everest sommerso da più di una tonnellata di spazzatura: ridurre la mole di rifiuti in alta quota è fondamentale ma serve ripensare l’intero approccio dell’alpinismo moderno delle grandi spedizioni. Sopra l’inceneritore italiano del Campo Base del K2 appena installato nel 2004 ci sono 377 ppm di CO2.
Arriviamo ai 150 anni dalla fondazione del Club Alpino Italiano. Nel 2013 a Torino, in una giornata di fine maggio, viene approvato il Nuovo Bidecalogo, scritto e aggiornato per essere in linea con le necessità dei tempi. Nell’atmosfera di Torino, in quel 26 maggio, ci sono 397 ppm di CO2. Si tratta di un documento ampio e approfondito, che contiene molte posizioni nette. Si affrontano temi centrali quali le nuove infrastrutture, il paesaggio, il cambiamento climatico, il turismo, la frequentazione delle montagne e le attività sportive. Leggendolo oggi, potremmo pensare che questo documento sia stato scritto solo pochi mesi fa. Bisogna dire che non sempre si è rispettato quello che è stato scritto: abbiamo tenuto per troppo tempo il tesoro sepolto nella cantina, senza mai capirne a pieno il suo valore e troppo spesso ci siamo fatti ingannare dall’idea di sviluppo economico che andava a discapito del patrimonio naturalistico e culturale delle nostre valli.
 Webcam Cervino, luglio 2022, zero termico a 5.184metri
Webcam Cervino, luglio 2022, zero termico a 5.184metriArriviamo infine ad oggi.
L’Italia (e in modo maggiore Alpi e Appennini) sono un "hotspot climatico", un luogo dove si osserva un aumento significativo della temperatura rispetto alla media globale e dove gli eventi estremi si intensificano. Gli incendi boschivi, la fusione senza precedenti dei ghiacciai, la “chiusura” di alcune delle vie alpinistiche più frequentate per rischio crolli, la siccità prolungata seguita da piogge torrenziali e lo zero termico che per la prima volta sfonda quota 5000m sono sintomi di un clima malato per colpa dell’ossessione dell’uomo verso un modello di sviluppo basato sui combustibili fossili.
In questi ultimi anni assistiamo a passi in avanti e inciampi da parte del CAI: nel 2017 il Club aderisce alla rete ASVIS (Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile) mentre a fine 2021 il documentario WeClub timidamente fa notare come le cascate di ghiaccio siano pressoché impraticabili a causa delle temperature invernali troppo elevate. Stacco immagine e ci si ritrova in aeroporto per andare a scalare in Sardegna.
Nel solo 2022 gli eventi estremi nel nostro paese sono aumentati del 55% rispetto l’anno prima: il riscaldamento globale non è un processo lineare e impatta l’ambiente montano in modo pensante.
Tutto questo ci pone davanti l’urgenza di dover ripensare a come ci rapportiamo alla montagna e nel frattempo arginare gli effetti della crisi climatica affinché l'eccezionalità non diventi la norma.
Nelle prossime settimane ci addentreremo nei report scientifici, cercando di comprendere come lo sport, il turismo, le comunità e il territorio delle Alpi e degli Appennini stanno cambiando a causa dei mutamenti climatici. I dati e la scienza saranno le nostre bussole in questa “selva” inesplorata che rappresenta la crisi climatica.
Concludendo, oggi sopra il cielo nuvoloso di Milano si dimenano 417 parti per milione di CO2.