.jpg) La Capanna Resegotti. Foto CAI Varallo.
La Capanna Resegotti. Foto CAI Varallo.C’è Rosalba Valsecchi, a cui il padre Davide intitolò il famoso rifugio in Grigna quando aveva appena un anno, segnando forse così la sua futura passione per la montagna. C’è Antonella Panepucci, fisica aquilana e alpinista di rilievo attiva sul Gran Sasso, dove l’intitolazione è seguita alla sua tragica scomparsa sul Canalone Bissolati al Corno Grande, nel ’79, da parte del CAI L’Aquila che con la recente ristrutturazione ne ha fatto un esempio di accessibilità in quota. E c’è ovviamente la Regina Margherita, per cui libertà era poter trascorrere del tempo a salire montagne e l’amato Monte Rosa più di tutti, dove a lei è intitolata la Capanna più alta d’Europa. Sono solo alcune delle figure prese in rassegna nel volume Dove è il mio cuore, di Camilla Maria Anselmi (pp. 312, 29,50 euro, MonteRosa Edizioni 2025), che rintraccia la biografia di tutte le donne a cui sono intitolati rifugi o bivacchi in Italia. Tutte, ma non molte sulla totalità delle dedicazioni, come vedremo.
Il libro, patrocinato anche dal CAI, è illustrato da Luca Pettarelli, in omaggio all’alpinismo dei pionieri, che rappresentavano i luoghi estremi in cui si recavano proprio con disegni fatti a mano, come Edward Whymper, primo salitore del Cervino, che deve proprio al suo mestiere di illustratore la passione per l’alpinismo.
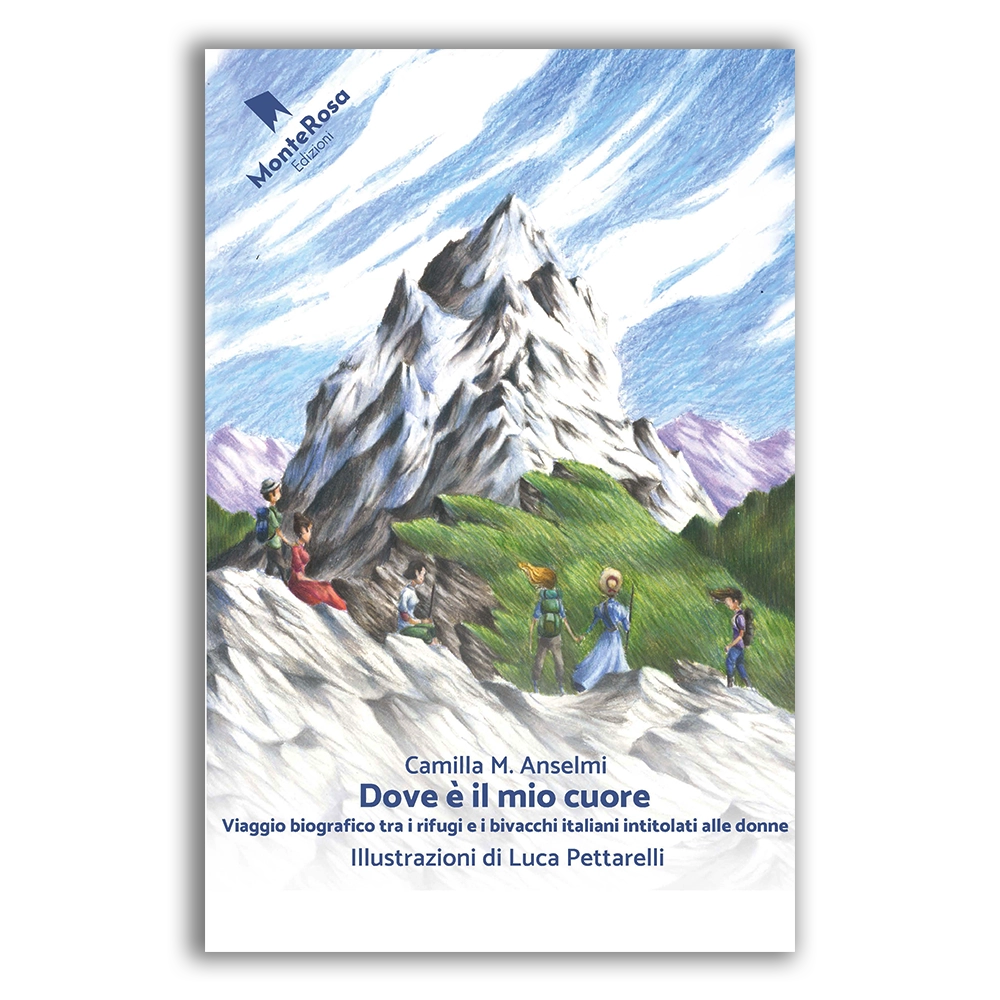 La copertina del libro.
La copertina del libro.È chiarissima Linda Cottino nella sua prefazione, mettendo subito in luce un dato: i rifugi e i bivacchi intitolati a donne sono ancora rari, poco oltre la cinquantina, esclusi quelli non più agibili o chiusi, a fronte di oltre 700 strutture in capo al solo CAI (760 quelle presenti sul portale Unico Rifugi CAI. Conferma l’autrice nell’introduzione che in effetti la sua ricerca, nata per curiosità l’estate del 2022 salendo al Bivacco Resegotti sul versante sud del Monte Rosa, non è stata affatto semplice: poche le informazioni, relegate spesso quasi solo in polverosi archivi di biblioteche locali, o nei casi più fortunati nella memoria di eredi, parenti o conoscenti ancora in vita delle dirette interessate. Per questo il libro contiene l'appello a chi ne sapesse di più a mettersi in contatto con l'autrice, che già pensa a una seconda edizione aggiornata.
A volte sono state proprio le testimonianze orali le uniche fonti, come per Cecilia Genisio, molto attiva nel CAI a livello nazionale e regionale, a cui nel 2021 le sezioni di Lanzo e Cuorgné hanno intitolato un nuovo bivacco costruito là dove lei lo pensava necessario, all’Alpe Vailet, nel Vallone di Vassola, sull’Alta Via del Canavese da lei tanto promossa, dopo essersi attivata per la nascita del raggruppamento intersezionale delle sezioni del Canavese e di Lanzo.
La rassegna di Camilla Anselmi, storica dell’arte milanese e appassionata di montagna, che finora aveva scritto solo libri per bambini, ha preso in considerazione 48 bivacchi o rifugi dislocati in 7 regioni ordinate alfabeticamente (Abruzzo, Friuli-Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte, Trentino-Alto Adige, Valle d’Aosta e Veneto), più 12 strutture non più esistenti, non agibili o chiuse, e infine altre 7 intitolazioni, fra cui quella del famoso Rifugio Elena in Val Ferret.
Compaiono rifugi e bivacchi assai noti di cui immaginiamo siano invece molto meno noti i nomi femminili associati, figuriamoci la relativa storia personale: come quella di Rosa Curioni del Marco e Rosa in Valtellina, Maria Rota Gerli del Rifugio Gerli-Porro sull’Alpe Ventina (il Porro è Augusto fratello di Lisetta, che pure fu eccelsa alpinista degli anni ’30), o di Antonietta Gatti, a cui è intitolato l’Antonietta al Pialeral in Grigna, Maria Luisa Milani del Maria Luisa in Val Formazza, Laura Florio dell’omonimo Bivacco sul Col du Créton, fra la Valpelline e la Valtournanche, Maria Vittoria Torrani del Rifugio al Pian della Tenda, sotto alla coma della Civetta.
Pochi in effetti i nomi più “famosi”: Antonia Pozzi, poetessa milanese, a cui il CAI Milano dedicò una delle camerate del Rifugio Brioschi sul Grignone, ricostruito dopo la Seconda guerra mondiale, Giovanna Zangrandi, scrittrice, staffetta partigiana e realizzatrice del Rifugio all’Antelao che le fu dedicato, e la Regina Margherita di Savoia, come citavamo all’inizio, dell’arcinota Capanna Osservatorio sul Monte Rosa. Bisogna già avere una buona conoscenza di storia dell’alpinismo per riconoscere quello di Alessandra Re Boarelli del bivacco sul Monviso, “la montagna di tutta la mia vita”, come scrisse lei che la salì come prima donna nel 1864, appena un anno dopo la prima ascensione italiana ad opera di Quintino Sella, il 12 agosto 1863, quella che diede vita al Club Alpino Italiano. Com’è noto, mancò per un soffio il primato: ma Quintino Sella le rese l’onore di intitolarle proprio la “maita” (il pianoro) dove lei (ma anche lui, coi compagni) aveva bivaccato, appena una settimana prima del suo passaggio, a 2820 metri presso i laghi di Forciolline. Il Bivacco Re Boarelli è sorto proprio lì, a imperitura memoria.
Le ultime intitolazioni, curiosamente, pare che siano avvenute all'estero: proprio la scorsa estate 2024 con il Cristina Castagna Center a Ghotolti, in Pakistan, per ricordare la vicentina morta sul Broad Peak nel 2009, nell'ambito di un più ampio progetto che il CAI ha organizzato per celebrare i 70 anni della salita al K2, o a Elena Senin nel 2011 sull'Aconcagua, dove l'alpinista era scomparsa nel 2009.
Le ragioni che hanno spinto parenti o amici a dedicare un rifugio o un bivacco a una donna sono quindi state diverse: per ricordare la memoria di chi è scomparsa tragicamente, di chi fu semplicemente cara, di chi compì in quei luoghi grandi imprese o di chi finanziò la struttura stessa. E quei nomi rimangono per sempre lì nel magnifico silenzio della montagna, là dove riposa il cuore di chi in vita tanto l’amò.